Pasqua laica e rivoluzionaria. Di conversione. Vi porto fuori porta ma solo metaforicamente. Restate chiusi nel vostro guscio!
Le metafore, peraltro, si sprecano e non sono nemmeno metafore. In clausura, letteralmente. Fuori si ode un grido disperato: «Questo patrimonio non s’ha da fare né ora mai!», perché tutti i facoltosi si dicono indignati dell’ipotesi di una patrimoniale (anche quando patrimoniale non è). Al massimo si fa beneficenza. Una sinistra talmente light che non si sente, non arriva.
Vi ricordo con enfasi che non abbiamo niente da perdere fuorché le nostre quarantene.
Eremiti, solitari, confinati in una nostra piccola, personale, privata Tebaide. E speriamo che siano tutti così. Che non ci sia alcuna rimpatriata. La parola stona, soprattutto ora. Nessuna rimpatriata, per la patria, ma per ciascuno di noi, che poi ci tocca stare chiusi fino a Ferragosto.
Ma torniamo al Manzoni, che ci dà il titolo e non parliamo di peste, che mi esce dagli occhi, la peste, la Corona Infame e tutto il resto. Parliamo dell’innominato. Che non è più lui.
«Il sarto si mise a parlare alla distesa della santa vita dell’innominato, e come, dall’essere il flagello de’ contorni, n’era divenuto l’esempio e il benefattore.
“E quella gente che teneva con sé?… tutta quella servitù?…” riprese don Abbondio, il quale n’aveva più d’una volta sentito dir qualcosa, ma non era mai quieto abbastanza.
“Sfrattati la più parte,” rispose il sarto: “e quelli che son rimasti, han mutato sistema, ma come! In somma è diventato quel castello una Tebaide: lei le sa queste cose.”»
Siamo verso la fine del romanzo dei romanzi, quando la minaccia è virale: si trattava allora dei lanzichenecchi, che avevano un tasso di mortalità altissimo, non facevano eccezioni, non si fermavano davanti a nessuno. Le bande alemanne, scatenate e avide di beni, di cose e di corpi. La pagina è magnifica. Prosegue, di lì a poco, così:
«Il sarto aveva detto la verità a don Abbondio, intorno all’innominato. Questo, dal giorno che l’abbiam lasciato, aveva sempre continuato a far ciò che allora s’era proposto, compensar danni, chieder pace, soccorrer poveri, sempre del bene in somma, secondo l’occasione. Quel coraggio che altre volte aveva mostrato nell’offendere e nel difendersi, ora lo mostrava nel non fare né l’una cosa né l’altra. Andava sempre solo e senz’armi, disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse, e persuaso che sarebbe commetterne una nuova l’usar la forza in difesa di chi era debitore di tanto e a tanti; persuaso che ogni male che gli venisse fatto, sarebbe un’ingiuria riguardo a Dio, ma riguardo a lui una giusta retribuzione; e che dell’ingiuria, lui meno d’ogni altro, aveva diritto di farsi punitore. Con tutto ciò, era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate, per la sua sicurezza, tante braccia e il suo. La rimembranza dell’antica ferocia, e la vista della mansuetudine presente, una, che doveva aver lasciati tanti desidèri di vendetta, l’altra, che la rendeva tanto agevole, cospiravano in vece a procacciargli e a mantenergli un’ammirazione, che gli serviva principalmente di salvaguardia. Era quell’uomo che nessuno aveva potuto umiliare, e che s’era umiliato da sé. I rancori, irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri, si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà: gli offesi avevano ottenuta, contro ogni aspettativa, e senza pericolo, una soddisfazione che non avrebbero potuta promettersi dalla più fortunata vendetta, la soddisfazione di vedere un tal uomo pentito de’ suoi torti, e partecipe, per dir così, della loro indegnazione.»
L’innominato non è più lui, non è la persona che era prima. È cambiato, irriconoscibile. La sua forza, che prima era tutta volta a far del male, si rivolge a fare del bene. Anzi, del benissimo. E allora molti trovano rifugio nel suo castello, divenuto luogo di pentimento e di conversione. E, quindi, di ospitalità per gli oppressi (anche oppressi è una parola che fa pensare al tempo presente). C’è qualcuno che però si ostina a non capire. Che non abbia coraggio lo sappiamo fin dalle prime pagine. Ma ora esagera.
«In molti? in molti?», si dispera don Abbondio, che preferirebbe non essere con troppe persone a cercare rifugio. Come a dire, meglio pochi, selezionatissimi. Perpetua interloquisce: «“Oh! voglion far altro che venir lassù,” diceva Perpetua: “anche loro devono andar per la loro strada. E poi, io ho sempre sentito dire che, ne’ pericoli, è meglio essere in molti.”»
È meglio essere in molti. In poche pagine, una guida, un tutorial, un modo di concepire quel cambiamento, quella conversione, nel momento del pericolo, della paura. Momenti in cui le opportunità si riducono e in cui le disuguaglianze quindi esplodono, in cui è tutto un salvarsi e un salvini chi può, in cui prevale il panico sulla lucidità, l’ansia sulla concretezza.
Sono proprio la solitudine, l’isolamento, la lontananza che ci dovrebbero far capire che serve essere in tanti e, se è possibile, tutti. A cercare salvezza. A trovarla, se ne saremo capaci.
State nel chiuso delle vostre uova, per schiudervi prima. La fretta fa i pulcini ciechi.


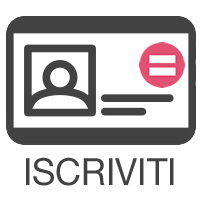






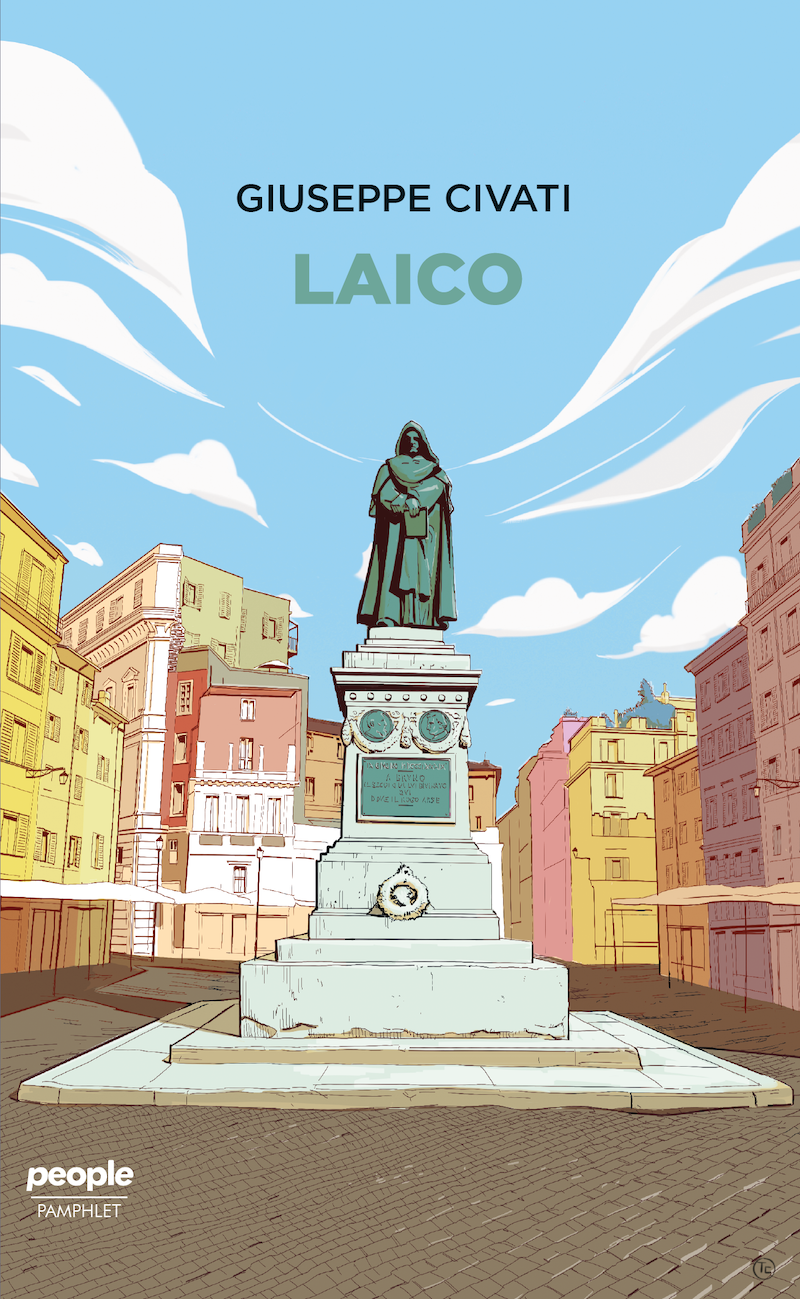

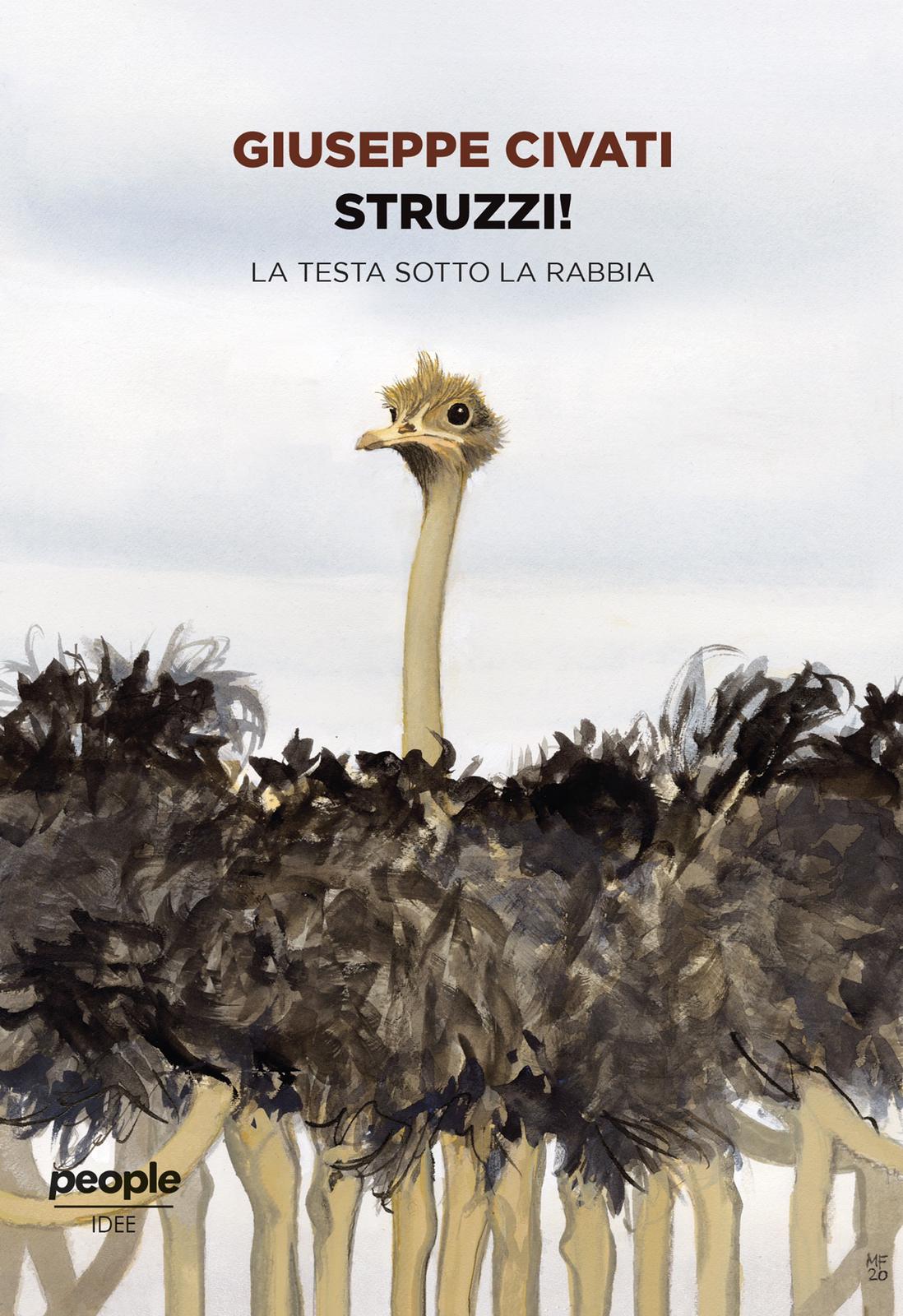








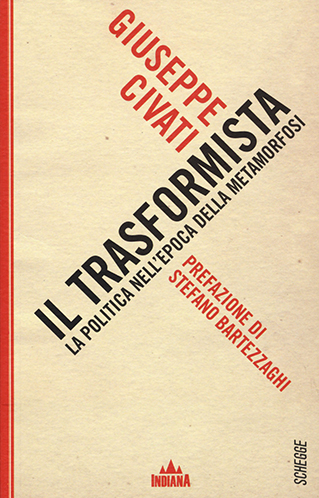


Comments (0)