
Somma Lombardo, a due passi da Malpensa, 5 ottobre 2019. È il festival delle scrittrici, «Scrittrici insieme», introdotto da una frase di Marie de France, che dice: «Amica, noi siamo così: non te senza me, non io senza te».
Con Helena Janeczek diamo la parola a Liliana Segre. Per Helena l’emozione è moltiplicata dalla storia di sua madre che è sopravvissuta a Auschwitz, come Liliana, perdendo tutti i suoi familiari (ne ha scritto in un libro bello e dolente, Lezioni di tenebra).
Liliana Segre va a ritroso, racconta di quando ricevette la telefonata dal Quirinale, pensando che fosse uno scherzo, mentre era in un negozio per una piccola commissione. Stava cercando le pile dell’orologio, rammenta, era un giorno qualsiasi. Quando la voce gentile che telefonava dal Colle le disse di attendere una chiamata dal Presidente della Repubblica, Segre chiamò una sua amica, con cui doveva andare al cinema, nel pomeriggio. Era «Come un gatto in tangenziale», ricorda Liliana ridendo.
Il Presidente Mattarella la chiamò, più tardi, e le disse che aveva firmato la sua nomina a senatrice a vita. Segre ringraziò pensando che a 88 anni era un riconoscimento curioso – pensò, ma non lo disse: «ancora un po’ che aspettavate…». In verità non si rende conto immediatamente dell’importanza di questa decisione, si confronta con Luciano, suo figlio, che si commuove. Le ricorda che cosa significa, qual è la solennità del momento.
Liliana Segre è così. Ironica, tagliente. Secca, si direbbe a Milano. Quando le chiedono selfie e autografi e si fa presente che quando la senatrice è stanca bisogna interrompere, lei serafica dice: «È successo dodici ore fa». L’ironia però lascia presto spazio alla gravità: «Quando il nostro bravo Presidente mi ha detto, con la sua voce mite e triste, che davanti a me si sarebbero aperte le porte del Senato, ho risposto che io sono ancora quella bambina, perché le persone anziane tornano sempre all’epoca della loro infanzia, a cui fu chiusa la porta della scuola, espulsa, unica della mia classe».
Dopo la sua liberazione, Segre rimase in silenzio su ciò che le era capitato dal 1938 al 1945, per quarantacinque anni. Non le andava di parlarne, se i figli le chiedevano che cosa significava quel numero sul suo avambraccio, rispondeva che glielo avrebbe detto quando sarebbero stati più grandi. Adulti. Voleva godersi la famiglia, ricorda oggi, la sua casa – una nuova casa – ritrovata, un’esistenza lontana dall’orrore. Nel 1990 però diventa nonna e allora pensa che la sua storia dimostra che lei ha vinto, che chi voleva sterminare le persone come lei non ce l’ha fatta, che deve portare testimonianza per tutti coloro che non sono potuti tornare.
«Mi sbloccò la nascita del mio nipotino, quella vita che usciva da me e dalla mia famiglia, mi convinse che era il momento di rivolgermi al mondo». All’inizio furono piccoli gruppi, fu un «vomito», dice Segre, «ci vuole proprio quella parola», poi furono classi e teatri e sale gremite, fino a incontrare 300 mila ragazzi, in tutta Italia.
Ragazzi – nipoti ideali, li chiama – a cui si rivolge come nonna e come bambina, auspicando che facciano quella che definisce la «scelta», che sentano l’urgenza di non distrarsi, di non cedere all’indifferenza, di prendere il suo testimone. Ne basta uno, in platea, che conservi la memoria, contro l’odio, contro la vendetta, per ricordare cosa successe allora, per evitare che accada ancora, perché il rischio è sempre presente. Incombente.
E lo ricorda pensando alla schedatura di ebrei e rom, quello Zigeunerlager, popolato da famiglie rom e sinti, che a Birkenau sparì in una notte. «Furono tutti bruciati, rimasero solo gli stracci nel vento, c’era molto vento, ad Auschwitz». E, ancora, lo chiede alle istituzioni, ricordando che lo stesso premier ha assunto l’impegno di muoversi lungo le linee del suo progetto di legge contro i discorsi dell’odio, perché ci siano finalmente strumenti per monitorare e controllare chi ancora lo adotta come strategia del consenso.
La platea è commossa e consapevole, come dovremmo essere tutti, noi italiani – come Liliana, che pur essendolo da centinaia di anni, fu esclusa dalla comunità e deportata. Come suo nonno, malato terminale di Parkinson, che fu venduto da una spia agli aguzzini e costretto su quel vagone per Auschwitz insieme alla moglie. Come suo padre, che il Presidente ha voluto ricordare quando nominò Segre senatrice, a cui va il pensiero di chi è genitore, pensando a cosa passò, quell’uomo, con l’angoscia di non poter salvare la figlia, di vederla clandestina, respinta, incarcerata e condotta al Lager. Lui fu ucciso, poche settimane dopo il loro ultimo saluto, sulla banchina che i nazisti dicevano degli ebrei, in quell’inferno di urla, di divise e di cani neri. Di violenza indicibile.
Lei è tornata, per rimanere, nelle nostre coscienze.
P.S.: Somma Lombardo può sembrare un posto qualsiasi, rispetto al suo racconto, ma la storia della fuga di Liliana Segre e della sua famiglia attraversa proprio quella porzione di Lombardia, tra Milano e la Svizzera, Castellanza e Viggiù. È una storia milanese, lombarda, italiana, la sua. Di persone perbene e di sciacalli. A proposito di certe schifezze che ancora circolano, come se questa storia non ci riguardasse. Ci riguarda. Invece. Eccome.


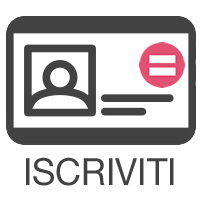






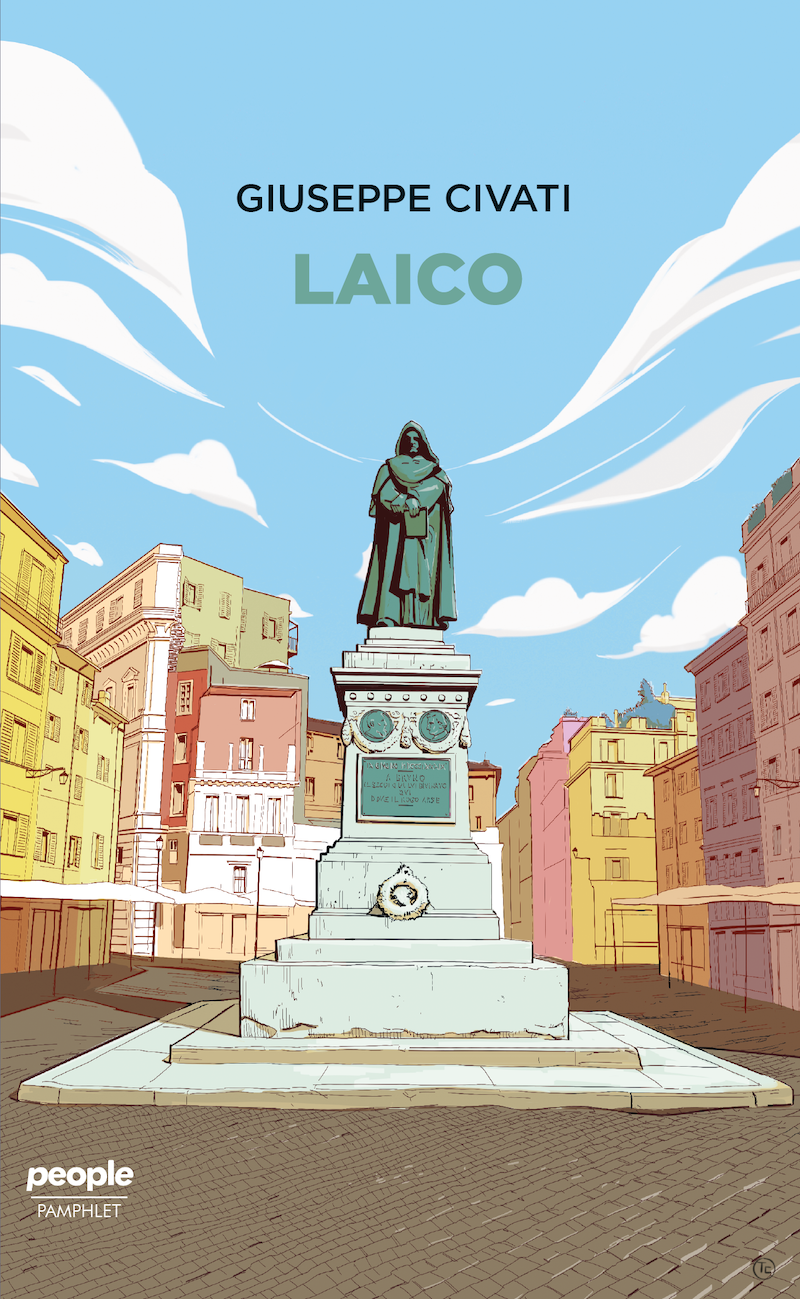

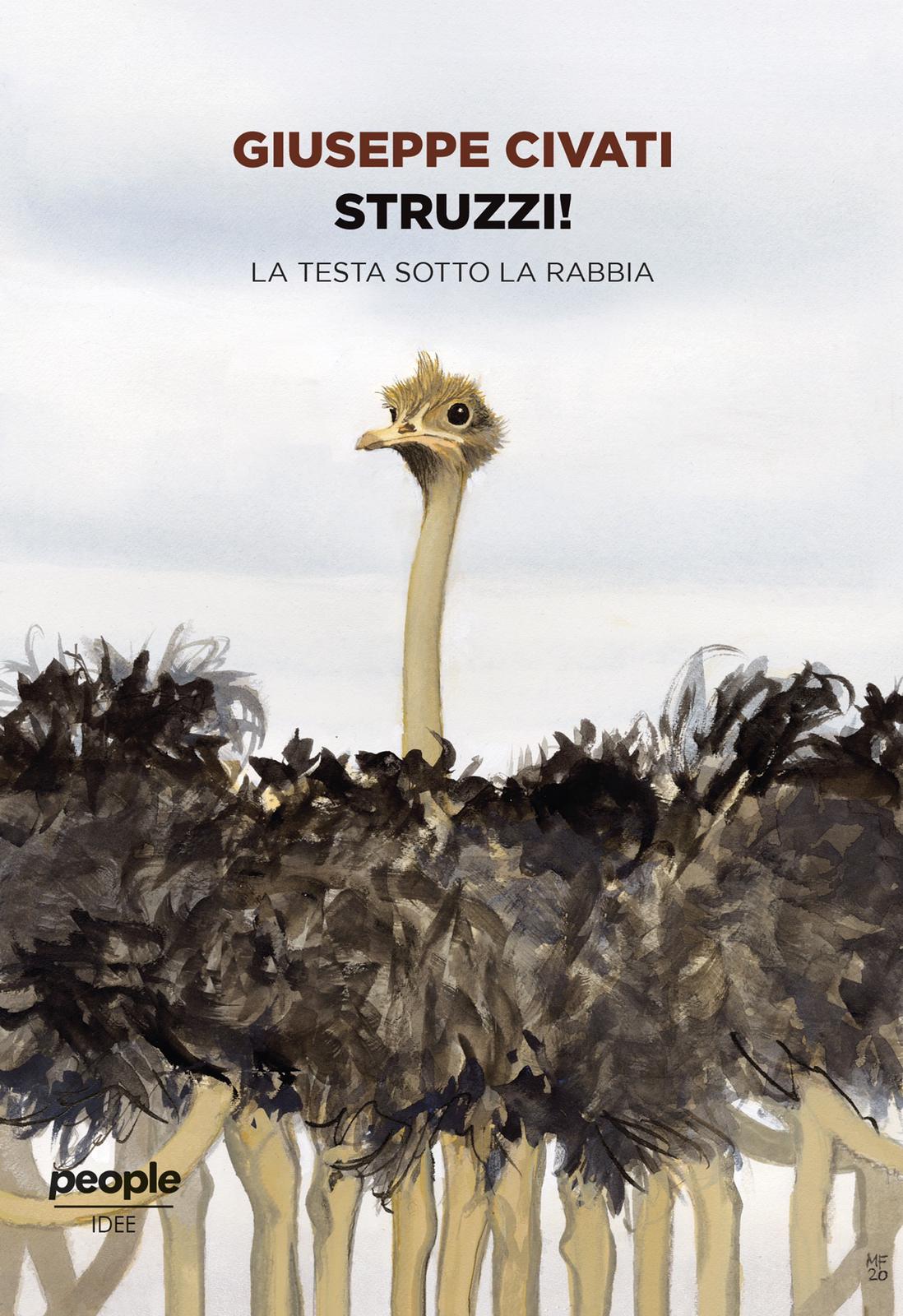








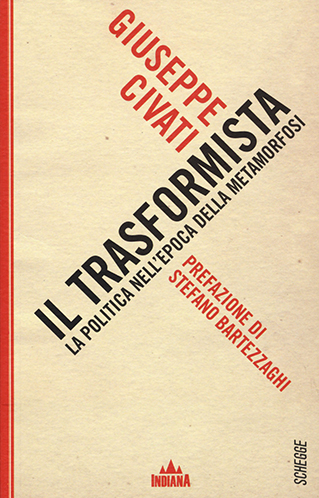


Comments (0)