
Prosegue il racconto di Giulia Montorzi (qui la prima puntata).
«Per un infettivologo, la creazione di un focolaio è il fallimento di una carriera.
Tale dogma impone un controllo oltremodo rigido di tutti gli accessi nei nosocomi perché, come ci insegnano le esperienze dei comuni della Bergamasca, i focolai intraospedalieri sono stati tra i veicoli principali della diffusione del contagio.
Questo impone di seguire scrupolosamente qualsiasi polmonite sospetta, ripetendo i tamponi se il risultato negativo del test non è consistente con la sintomatologia.
Questo vuol dire proteggere le sale operatorie testando ogni ingresso col legittimo sospetto che possa trattarsi, ancora una volta, di un positivo asintomatico.
Nella fase di mezzo, da fine febbraio all’istituzione della zona rossa, le persone si spostavano e si recavano in ospedale con la febbre. Sebbene la direttiva ministeriale imponesse di considerare a rischio solo i pazienti venuti in contatto con la zona del Lodigiano, non era possibile pensare che questa opzione fosse realistica: soprattutto in una regione come la Lombardia, in cui entrano e dalla quale si spostano quotidianamente milioni di individui.
Si è iniziato a parlare di “Fase 2”, ma prima di arrivarci sarà obbligatorio pensare ad uno step intermedio di controllo degli asintomatici e delle sierologie, durante il quale i test virologici saranno i protagonisti, al fine di controllare la reale diffusione della malattia: non sarà possibile tornare alla normalità se non conosceremo il numero degli infetti e, soprattutto, dei possibili contagiosi.
E l’impressione è che stiamo ripetendo lo stesso errore della “Fase 1”: riaprire senza una chiaro indirizzo di politica sanitaria pubblica di controllo potrebbe portare a rischio di nuovi cicli di contagio. Dobbiamo immaginare la società come un grande ospedale: il reparto bolla, quello degli infetti, non deve contaminare la zona pulita, cioè il resto della collettività».



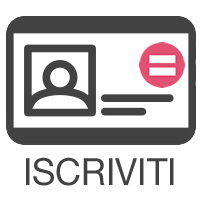








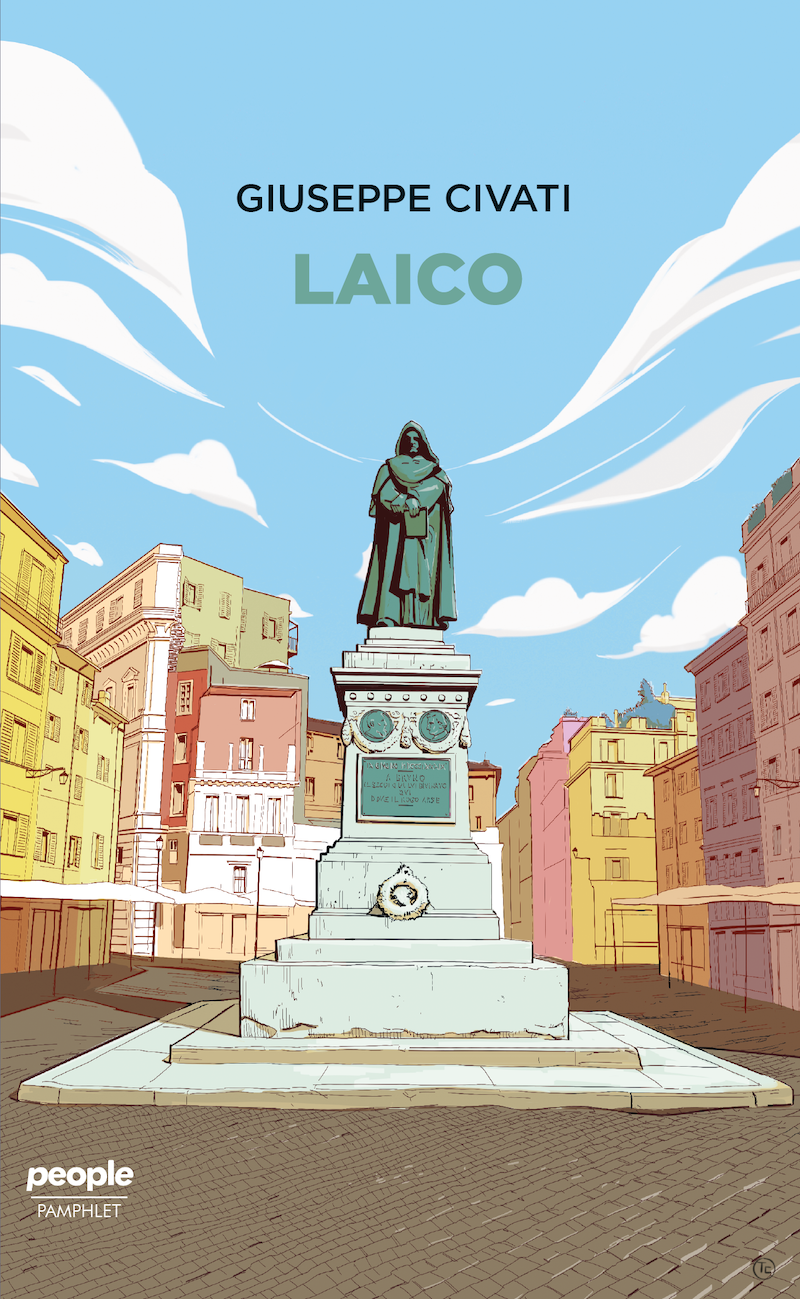










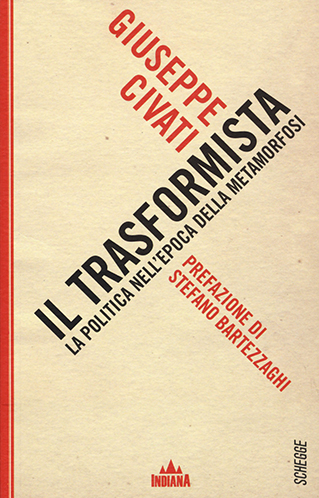


Comments (0)