Ognuno di noi ha, nella propria vita, Un eterno giovedì. Il giovedì di Pierfrancesco Majorino (lontanissimo parente di quello fantastico di John Steinbeck) è l’occasione per un romanzo, difficile, duro, che ti costringe ad inseguire un flusso di coscienza che passa di padre in figlio, alla ricerca di un filo sottile della memoria che si perderebbe se non fosse sorretto dalla prosa quasi magica del mio caro amico e collega. Come l’alba dell’ultimo Veltroni, anche il giovedì di Majorino è periodizzante, divide in due le vite e i destini, invita al ricordo e alla ricostruzione dell’esistenza che non è mai di uno solo, ma è familiare e sempre relazionale: in una parola, collettiva. Ed è storia, insomma, in cui riconoscere «un lungo e tormentato viavai di ricordi e impressioni» che costellano il libro, in un crescendo straordinario, allorché si tratta di raccontare la fuga. Perché Un eterno giovedì è un libro sulla fuga, anzi è letteralmente una fuga, nel passato, verso una memoria che è insieme la sua perdita. Anzi, per essere più precisi, è una memoria che è immediatamente la sua lontananza: perché la fuga, una cosa è certa, non si può impedire. E allora «la pietra cresce, diventa pendio, salita e montagna. Piove, Manuela, e mi riparo in una grotta che abita il monte e, fuori, i tuoni rimbombano lontano di un tetro rumore…». Dopo i lampi, per parafrasare l’usteron proteron che fa da titolo al suo primo romanzo, altri ne sono venuti. E altri ne verranno.


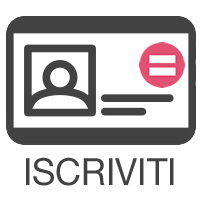






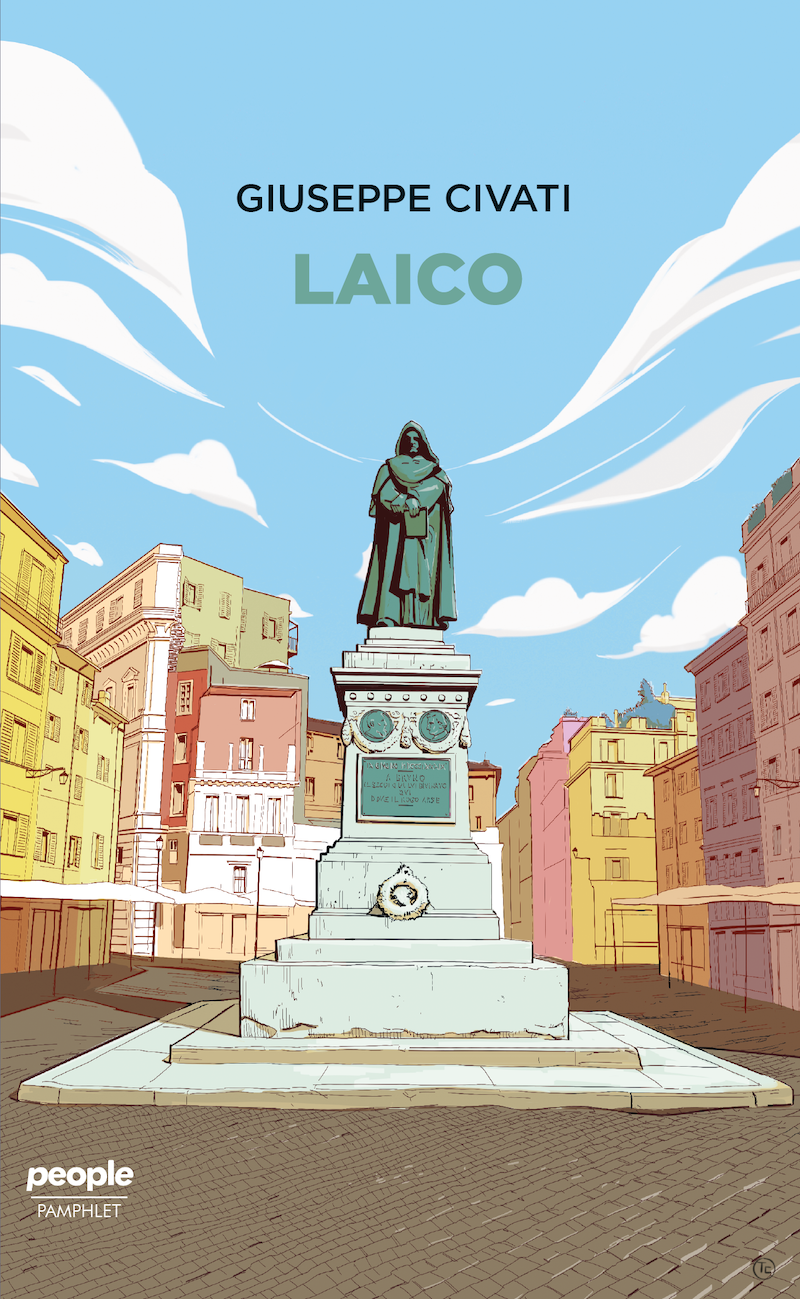

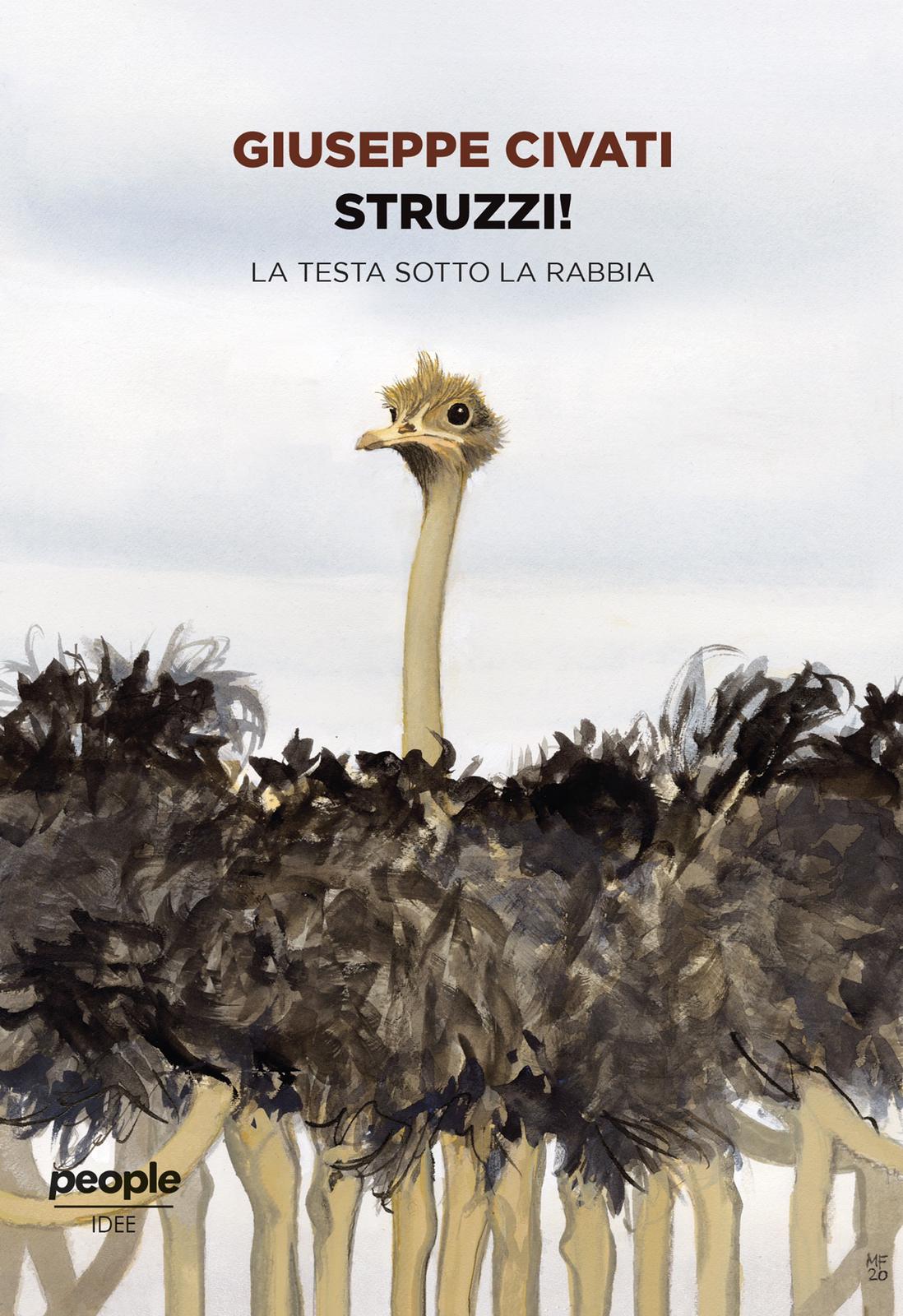








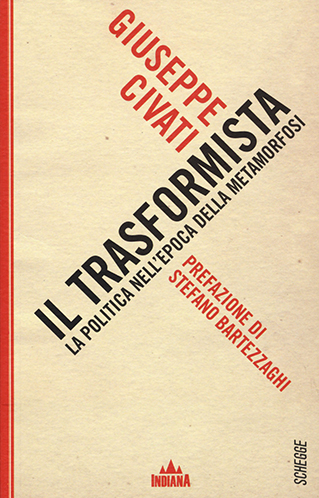


Comments (0)