
La testimonianza di Liliana Segre attraversa le generazioni. I suoi nonni, il papà Alberto, i suoi figli e i suoi nipoti. E lei, da nonna, che si rivolge a quelli che definisce i suoi «nipoti ideali». La scelta del punto di vista di ogni suo intervento è duplice: tornare bambina, per raccontare cosa accadde a lei e alla sua famiglia dal 1938 al 1945, e rivolgersi ai giovanissimi di oggi, che hanno l’età che lei aveva allora. Raccontare le leggi razziali (razziste!) e ciò che accadde dopo, dieci anni dopo, con la Costituzione della Repubblica. E quindi chiedere che quel testimone non cada, che altri lo raccolgano. Di generazione in generazione, appunto.
Oggi la Senatrice ha ricevuto il dottorato in Storia dell’Europa honoris causa all’Università La Sapienza di Roma. E l’ha dedicato a suo padre, «l’uomo più importante della mia vita», dice sempre, che fu costretto a soffrire e vedere la figlia soffrire, in fuga con lui, clandestina, richiedente asilo, respinta, arrestata, deportata ad Auschwitz. Liliana lo avrebbe visto per l’ultima volta sulla banchina della stazione degli orrori del campo di sterminio. E lo avrebbe salutato come fanno le bambine con i genitori, facendogli ciao con la manina, mandandogli dei baci, convinta che l’avrebbe rivisto dopo poche ore. Non lo rivide più.
Il rapporto tra padre e figlia è senza dubbio ciò che più colpisce del suo racconto e spesso Segre rappresenta ai suoi giovani nipoti l’angoscia del papà che non riesce a mettere in salvo la figlia. La disperazione che lo accompagna. Già il Presidente Mattarella, quando la nominò senatrice, disse che firmando il decreto che la riguardava aveva pensato a suo padre. E, coerentemente, a suo padre e alla sua memoria è dedicato il nostro libro.
Ai nostalgici della dittatura, a chi dice di non trovare insultanti le discriminazioni, a chi ammette la violenza e l’esclusione come necessarie, raccontate questa storia. Fatelo, ogni volta che potete. E pensate a Alberto Segre.


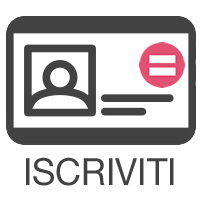






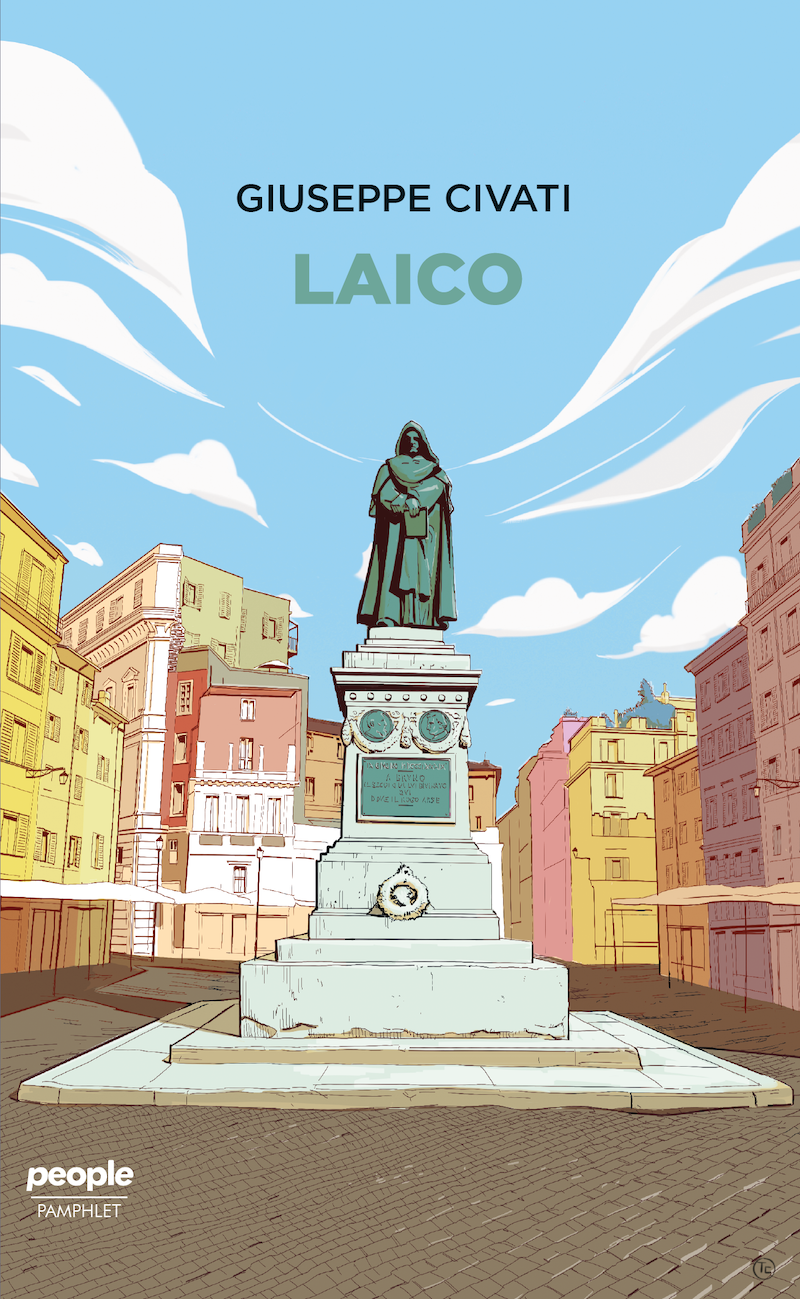

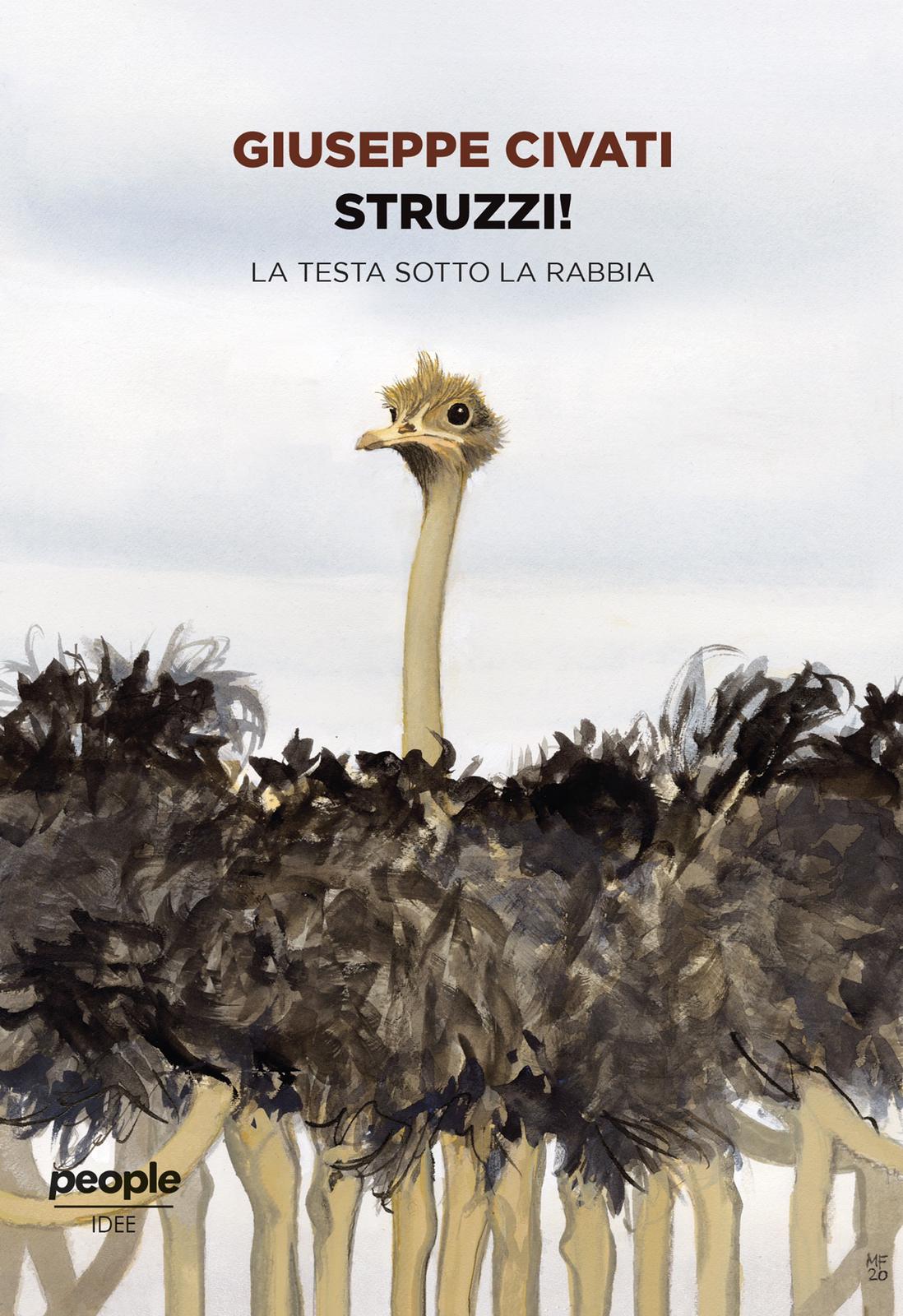








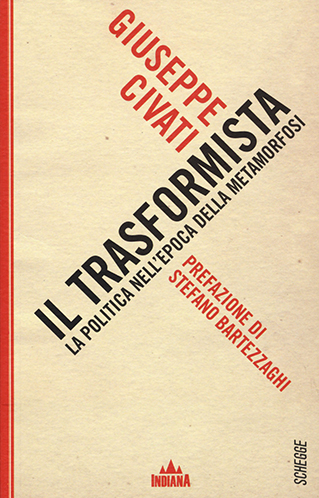


Comments (0)