Un estratto della breve introduzione allo straordinario monologo di Giulio Cavalli – con la collaborazione di Nello Scavo – che People pubblica, con grande onore: A casa loro.

Tutto parla di noi. Il mare. Nostrum. Le nostre vecchie colonie, una ricca di petrolio, l’altra poverissima. Tutto parla di noi, anche se noi, di noi, non parliamo mai. Parliamo di loro. Come se non fossimo stati noi, ad andare da loro. Come se non avessimo condizionato le loro vite. E anche la loro morte. Come se non lo stessimo facendo ancora e non stessimo facendo di tutto per non perdere il controllo su di loro, sulla loro vita, sulla loro terra, sull’estrazione di materie preziose – per noi – e sulla produzione di beni economici – per noi – a costo di violare loro, i loro diritti, la loro stessa esistenza.
«A casa loro», a dispetto del titolo, e in ragione del tentativo di abbattere una retorica insana una volta per tutte, parla di noi. Come dovremmo sempre fare, prima di parlare di loro. E per farlo, ascoltare le loro storie. Fare nostro il loro punto di vista. Metterci nei loro panni, sdruciti, sudici, consumati da un logorio che li ha in molti casi devastati.
Del resto, è fin dalla nostra mitologia che di ciò si parla. Con Giulio lo ricordiamo a ogni replica, di un altro spettacolo, fratello di questo monologo («Sono tutti uguali»). Enea era un profugo, Virgilio lo dice subito, al secondo verso. Secco. Ed era un profugo che muoveva da Oriente, con il padre Anchise, con il figliolo Ascanio (la moglie si perse, nella fuga, nella notte in cui la città bruciava). E ce lo dice con ancora maggiore chiarezza, quando Enea, sloggiato da casa sua, si reca «a casa loro». In Libia, come si chiamava tutta quella grande porzione di Nord Africa. E trova un popolo che non è disposto ad accoglierlo, che anzi fa letteralmente fuoco e fiamme per non avere in casa i troiani. Per respingerli dalle proprie coste, per rimandarli al posto dal quale sono venuti. I profughi. Stanno costruendo la loro, di casa, la grande città di Cartagine, e non hanno intenzione di ospitarli.
La supplica dei troiani è accorata: «Ma che popolo è questo? Che barbara patria / permette una simile usanza? L’asilo della sabbia ci negano, / fan guerra, ci vietano di porre piede sul lido!» (Eneide, I, 539-541, traduzione di Rosa Calzecchi Onesti per Einaudi).
Ed è Didone, a casa sua, a ricordarci perché invece Enea e i suoi miseri compagni vadano accolti. Perché anche loro dalla loro casa, a Oriente – era Tiro, oggi parleremmo di Siria o più precisamente di Libano, il paese che accoglie il maggior numero di profughi per abitante – erano stati espulsi. E il fatto di aver trovato terra non è una buona ragione per respingere i troiani, ma anzi per accoglierli. «O giovani, presto dunque, entrate nel nostro palazzo», nella nostra casa, dice Didone. «Me pure una simile sorte con molto patire agitava», aggiunge, «e qui finalmente, in questo paese, volli fermarmi». Del resto «Non ignara di mali, ho appreso a soccorrere i miseri» (Eneide, I, 627-630).
È questa una legge che precede ogni codificazione.


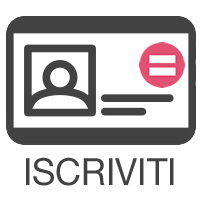






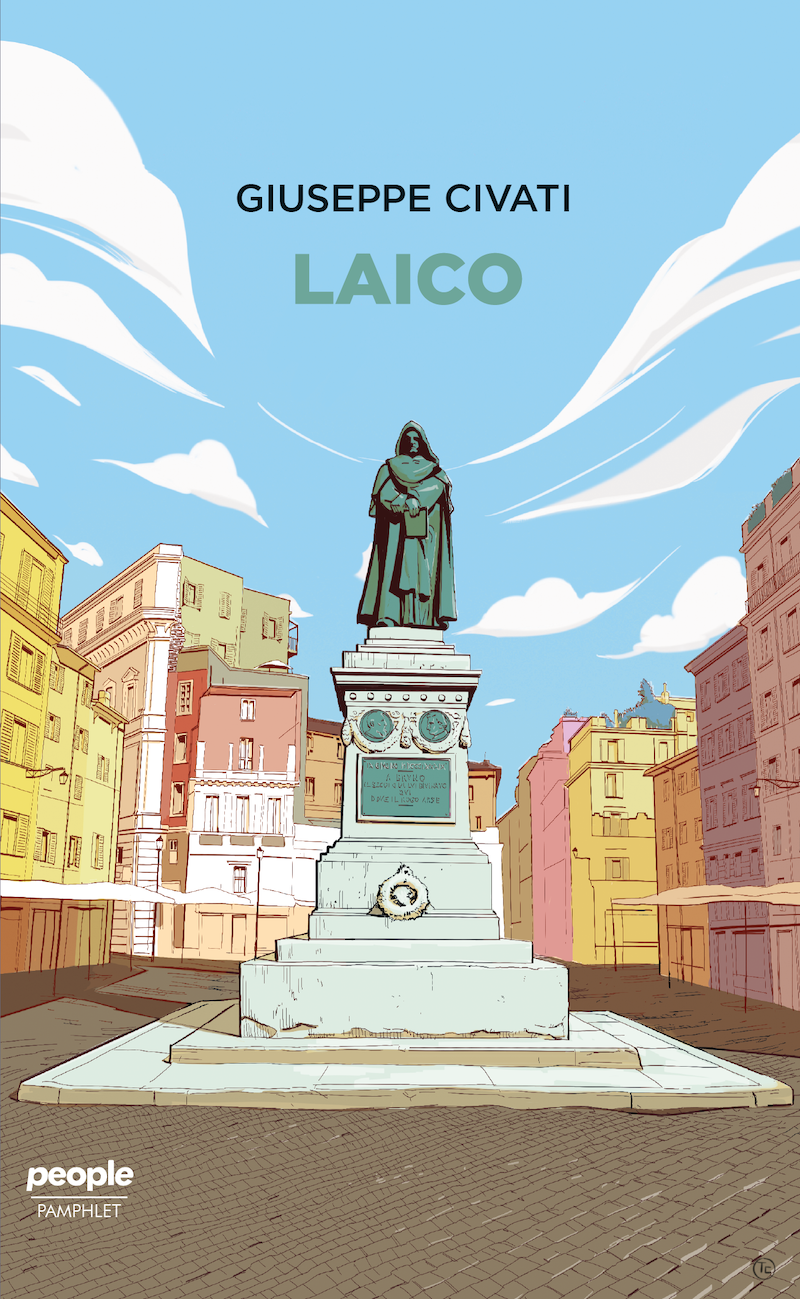

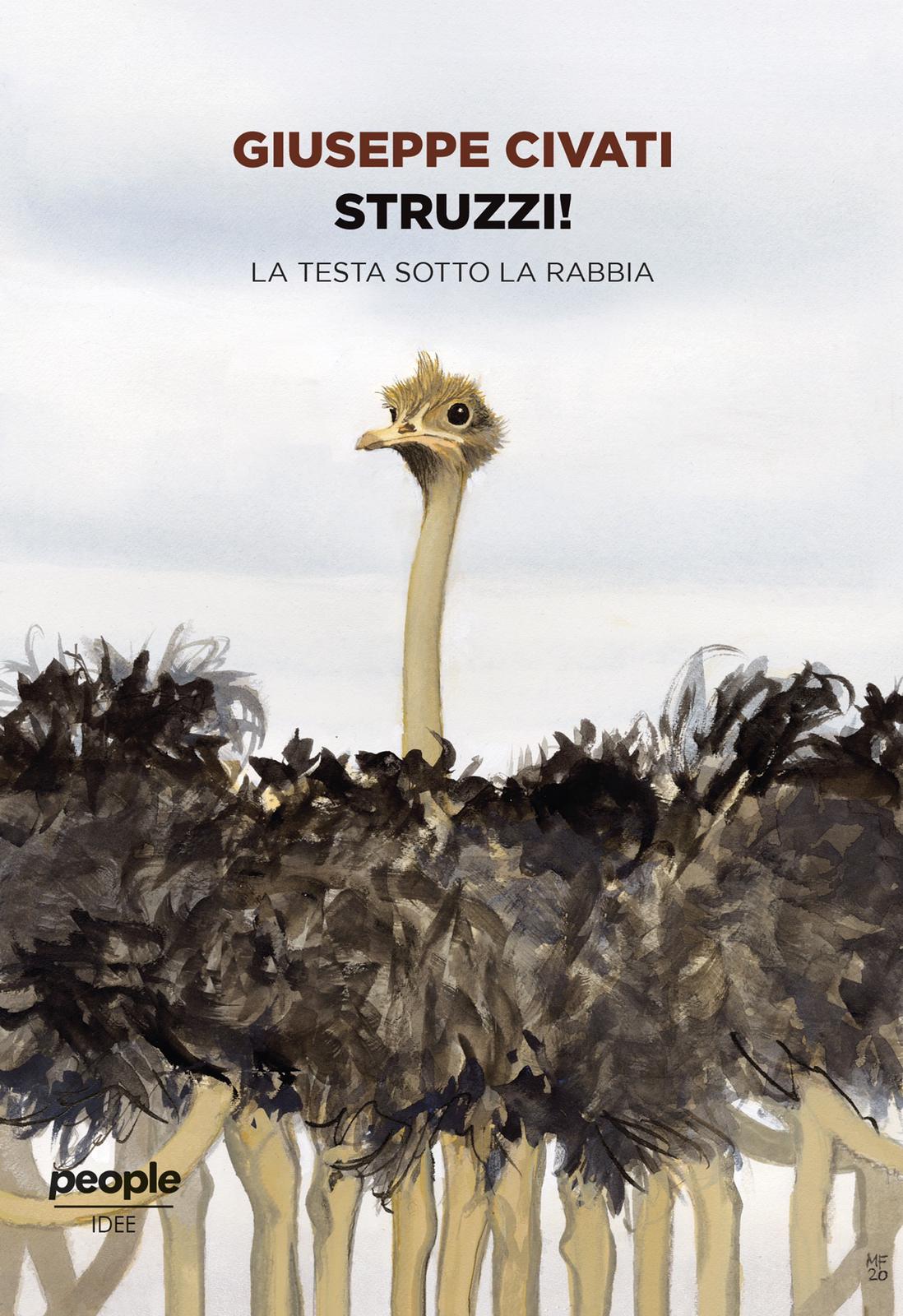








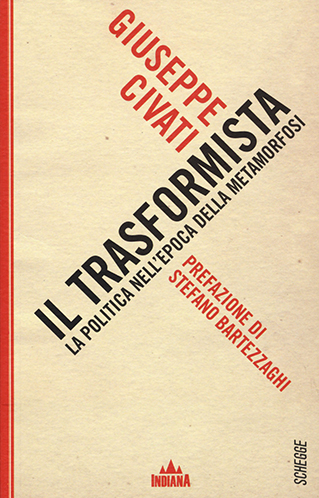


Comments (0)