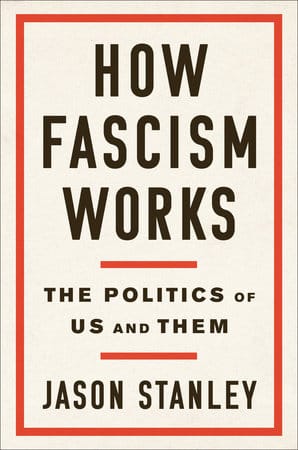 La trappola della normalizzazione: la descrive spesso Liliana Segre, quando racconta ai ragazzi la sua storia, nella quale è stato fatale per interi paesi e per il destino di milioni di persone abituarsi all’abominevole. Un processo che avviene piano piano, impercettibilmente, ogni giorno un passo più in là.
La trappola della normalizzazione: la descrive spesso Liliana Segre, quando racconta ai ragazzi la sua storia, nella quale è stato fatale per interi paesi e per il destino di milioni di persone abituarsi all’abominevole. Un processo che avviene piano piano, impercettibilmente, ogni giorno un passo più in là.
Nel libro di Jason Stanley, How Fascism Works: The Politics of Us and Them, pubblicato qualche giorno fa negli Stati Uniti, si spiega diffusamente il funzionamento della normalizzazione, una trappola nella quale cadono in molti. Chi – da un pubblico istituzionale, soprattutto – afferma e ripete cose indegne, le rende anche normali, abituali e insomma ‘giuste’:
Il filosofo di Yale Joshua Knobe e il suo collega psicologo Adam Bear hanno dimostrato che i giudizi su ciò che è normale sono influenzati sia da ciò che le persone ritengono statisticamente normale che da ciò che ritengono idealmente normale, cioè appropriato e sano (ad esempio, quante ore al giorno di televisione si dovrebbero guardare). In un articolo per la New York Times Sunday Review, hanno applicato le loro conclusioni ai nostri giudizi rispetto al mondo sociale, scoprendo che la costante condotta del Presidente Trump – azioni e dichiarazioni che sarebbero state considerate fuori dal normale – hanno conseguenze reali e disturbanti: «Quelle azioni non solo vengono considerate sempre più come tipiche, ma anche normali. Come risultato, verranno viste come meno gravi e meno meritevoli di indignazione.»
Le ricerche di Knobe e Bear forniscono una base per un fenomeno che coloro i quali hanno assistito alla transizione dalla democrazia al fascismo tendono, per esperienza personale, a enfatizzare con grande allarme: la tendenza della popolazione a normalizzare l’impensabile.
C’è un tema centrale nelle memorie del 1957 di mia nonna Ilse Stanley, The Unforgotten. Mia nonna rimase a Berlino fino all’ultimo momento possibile, nel luglio del 1939, in modo da poter lavorare clandestinamente. Dal 1936 sino alla Kristallnacht, si avventurava nel campo di concentramento di Sachsenhausen, vestita come un’assistente sociale nazista, salvando dalla morte centinaia di ebrei detenuti là, uno alla volta. Nel suo libro, racconta la disparità tra gli estremi a cui assistette nei campi di concentramento e il rifiuto della gravità della situazione, la sua normalizzazione, da parte della comunità ebraica di Berlino.
Fece fatica a convincere i suoi vicini della verità:
«Un campo di concentramento, per quelli che stavano fuori, era una sorta di campo di lavoro. Si vociferava di persone che erano picchiate, persino uccise. Ma nessuno pareva realizzare la tragicità della realtà. Eravamo ancora in grado di lasciare il paese; potevamo ancora vivere nelle nostre case; potevamo ancora recarci nei nostri templi; eravamo in un ghetto, ma la maggior parte della nostra gente era ancora viva. Per l’ebreo medio, questo era sufficiente. Non si rendeva conto che stavamo tutti aspettando la fine. Era il 1937.»
Il libro di Jason Stanley è prezioso, perché – come già scriveva Umberto Eco, molti anni fa – il fascismo ritorna, in parte o tutto intero, nei nostri schemi culturali e politici e chi lo nega è perché non se ne rende conto, subisce la normalizzazione o si abitua al suo linguaggio. Stanley ha il merito di spiegarlo, parlando di ciò che accade oggi, in una dialettica tra noi e loro che è la madre di tutti i fascismi e delle loro declinazioni.


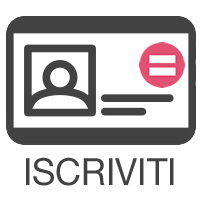






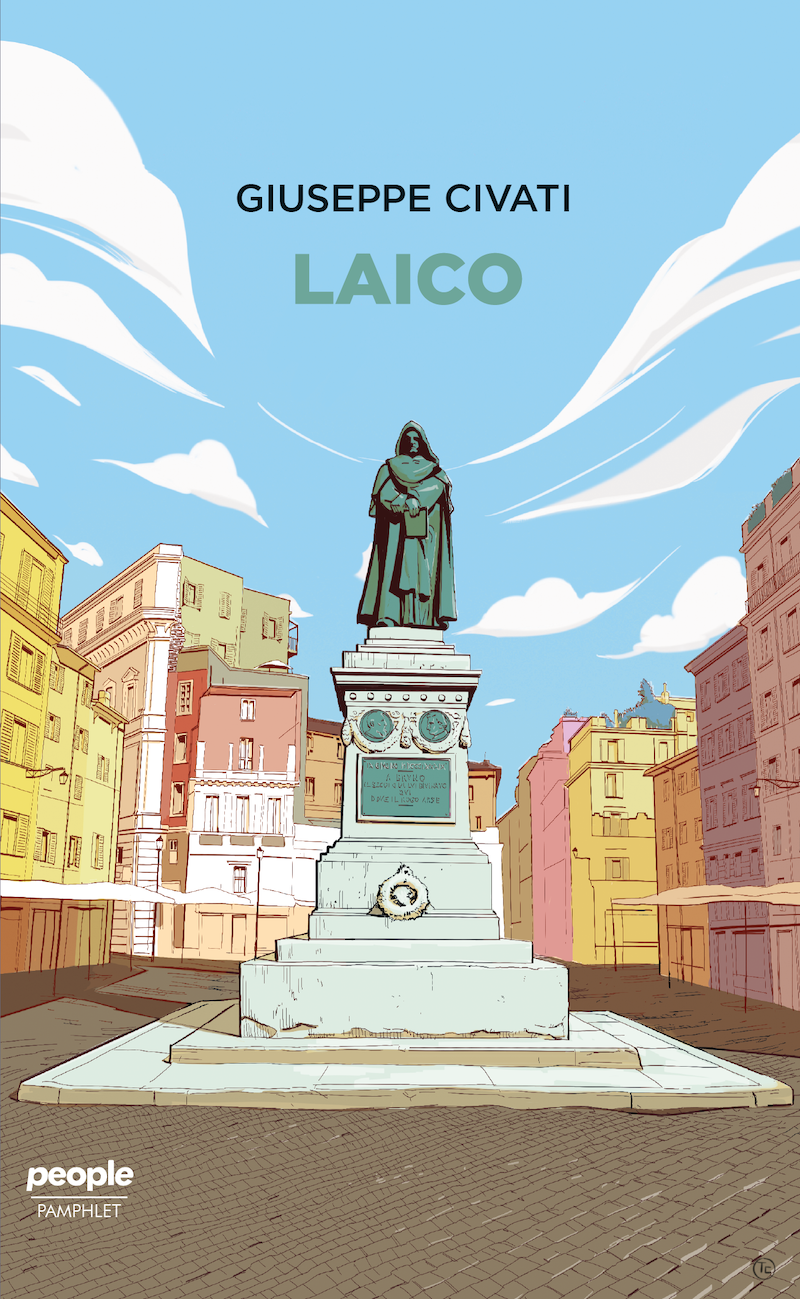

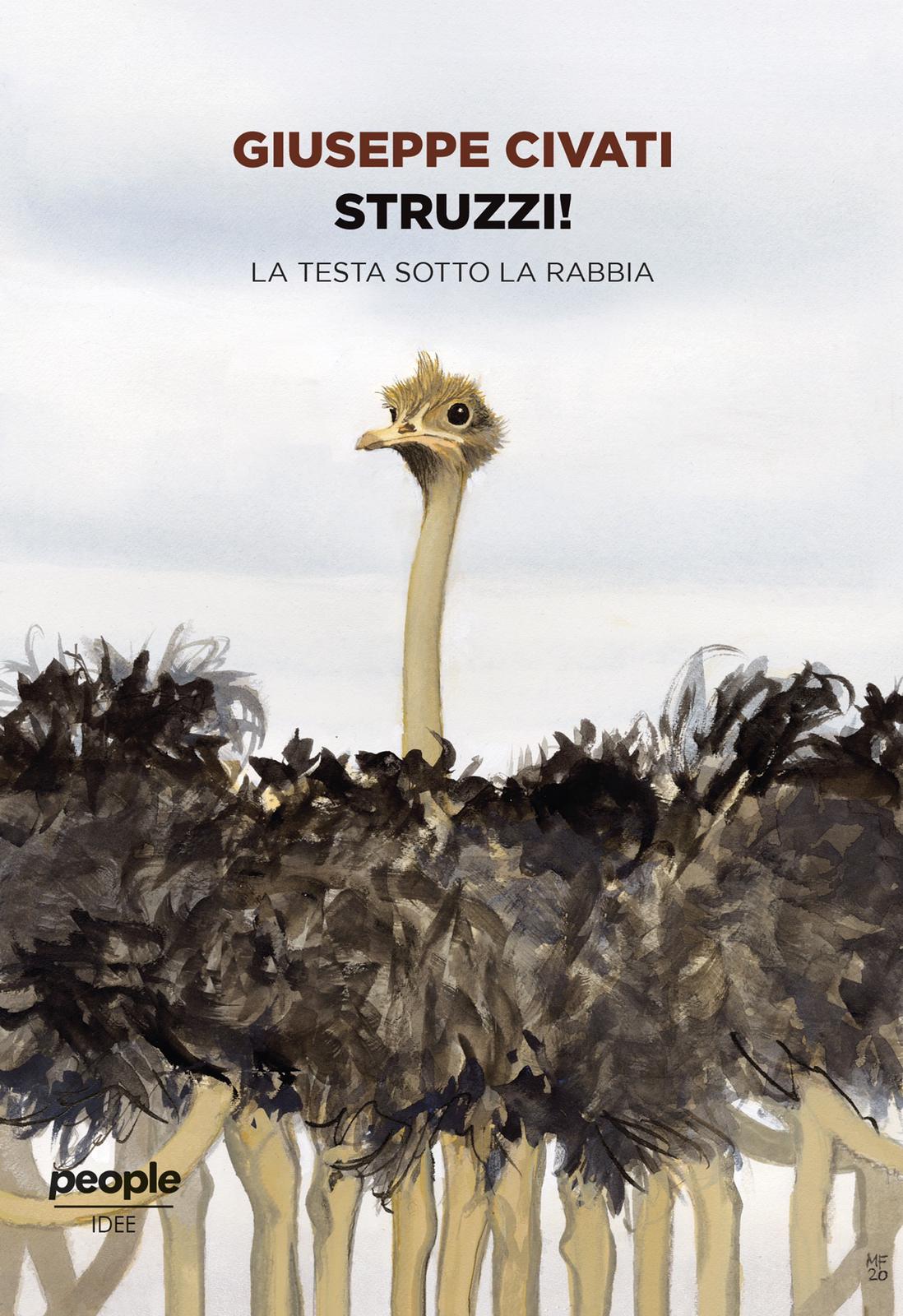








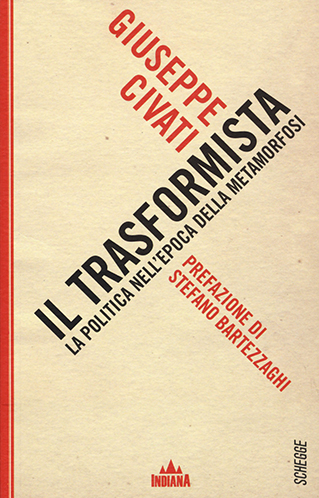


Comments (0)