Oggi Paolo Franchi scrive cose molto condivisibili sul futuro del Pd e sulla 'mossa' che in molti si attendono da parte di Bersani sul caso Penati e non solo.
Già nel corso della stagione congressuale ponemmo il problema della concezione della politica a cui il Pd si voleva ispirare. Ci fu risposto che la politica e la stessa guida del Pd erano «cosa per professionisti», tanto che era «curioso» che noi candidassimo un «dottore» alla segreteria del partito. Applausi.
Ci fu detto, poi, che non ci dovevamo lamentare di cose strane come il tesseramento di Napoli, perché tutto sommato non c'era niente di male, si fa così, e poi non importa se le primarie finiscono male come sono finite.
Ci fu spiegato che l'idea del ricambio, in politica, è scivolosa, perché se poi mandi via quelli bravi è difficile continuare il lavoro intrapreso. Anche se perdono, quelli bravi, per capirci.
Negli ultimi tempi le nostre battaglie 'storiche' – limite dei mandati, primarie per scegliere i parlamentari, riduzione dei costi della politica, superamento dei vitalizi e di altre questioni ancora aperte (a cominciare dalle province, di cui parlai a gennaio, al Lingotto, tra molte alzate di spalle) – sono diventate oggetto di mille interviste, tanto che il sindaco di Bologna (che diceva di noi che eravamo «golpisti» solo un anno fa) riprende gli stessi argomenti. Con grande slancio.
Ciò che manca è la visione che tiene insieme tutte queste cose, una concezione della politica aperta e non esclusiva, una dimensione del potere limitata (sous rature, si direbbe in termini filosofici) e immediatamente piegata al servizio e alla concorrenza leale (due concetti che provengono da mondi lontani, e che convergono, però, se si vogliono fare meglio le cose), una idiosincrasia per tutti quelli che in politica esagerano nei toni, nei condizionamenti e nella costituzione di gruppi più o meno potenti, più o meno legittimi (e legali). Un'idea di leadership rigorosa e trasparente, aperta e inclusiva.
«Il tempo e la dote», diceva Dante, tanto tempo fa. E parlava di Cacciaguida e di una Firenze che, già allora, non c'era più. Della dote, si è detto parecchio, in questi mesi, per poi fare poco o nulla. Del tempo, invece, si dovrebbe dire di più.
Perché una generazione è passata, dopo il 1992. Perché è cambiato il mondo, fuori, e dentro la politica è, se possibile, peggiorata. E tutte queste cose danno il segno della necessità di un cambiamento di passo. Culturale e politico.
Prendersi il tempo e darsi il tempo, in questo senso, vanno insieme. Perché non abbiamo bisogno di «padreterni», ma di partiti e di politici che prendano lezioni (abominevole essendo il detto: «non accettiamo lezioni da nessuno», con i risultati che sappiamo), che ripensino se stessi e il tempo e la dote, prima di ogni altra cosa. E non superino la «misura», perché vivono nella relazione e nella rappresentanza. E sanno di poterlo fare per un po' di tempo, non per sempre. E di avere un tempo, passato il quale, toccherà ad altri fare la stessa cosa.
Di uomini forti e prepotenti è piena la letteratura politica del nostro Paese, fin dalla notte della repubblica e forse dei tempi.
Ma il tempo è quello del futuro, ricorda Franchi. Poi anche il futuro passerà. E forse è il momento di entrare nel nostro. Prima che sia troppo tardi. Per la politica e per il nostro Paese.


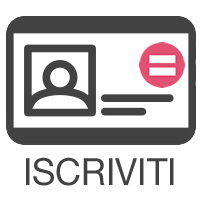






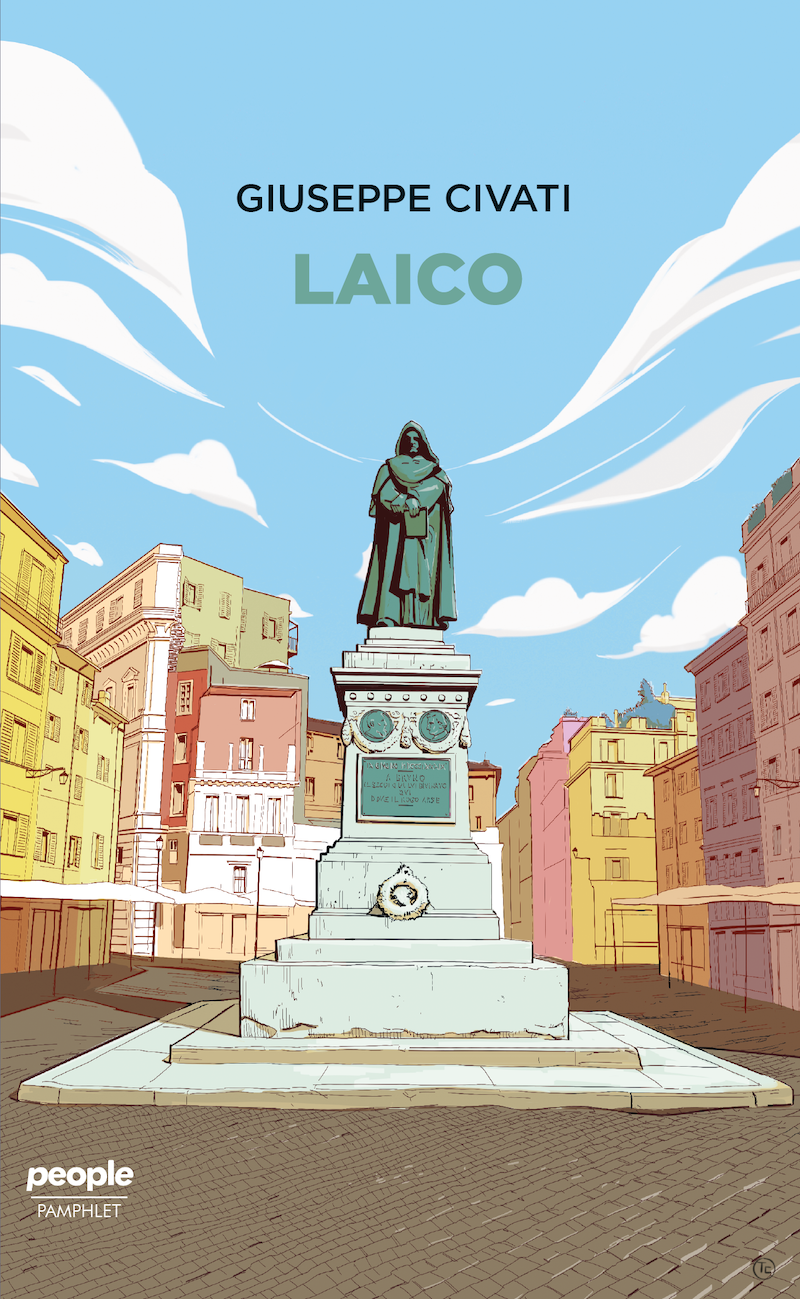

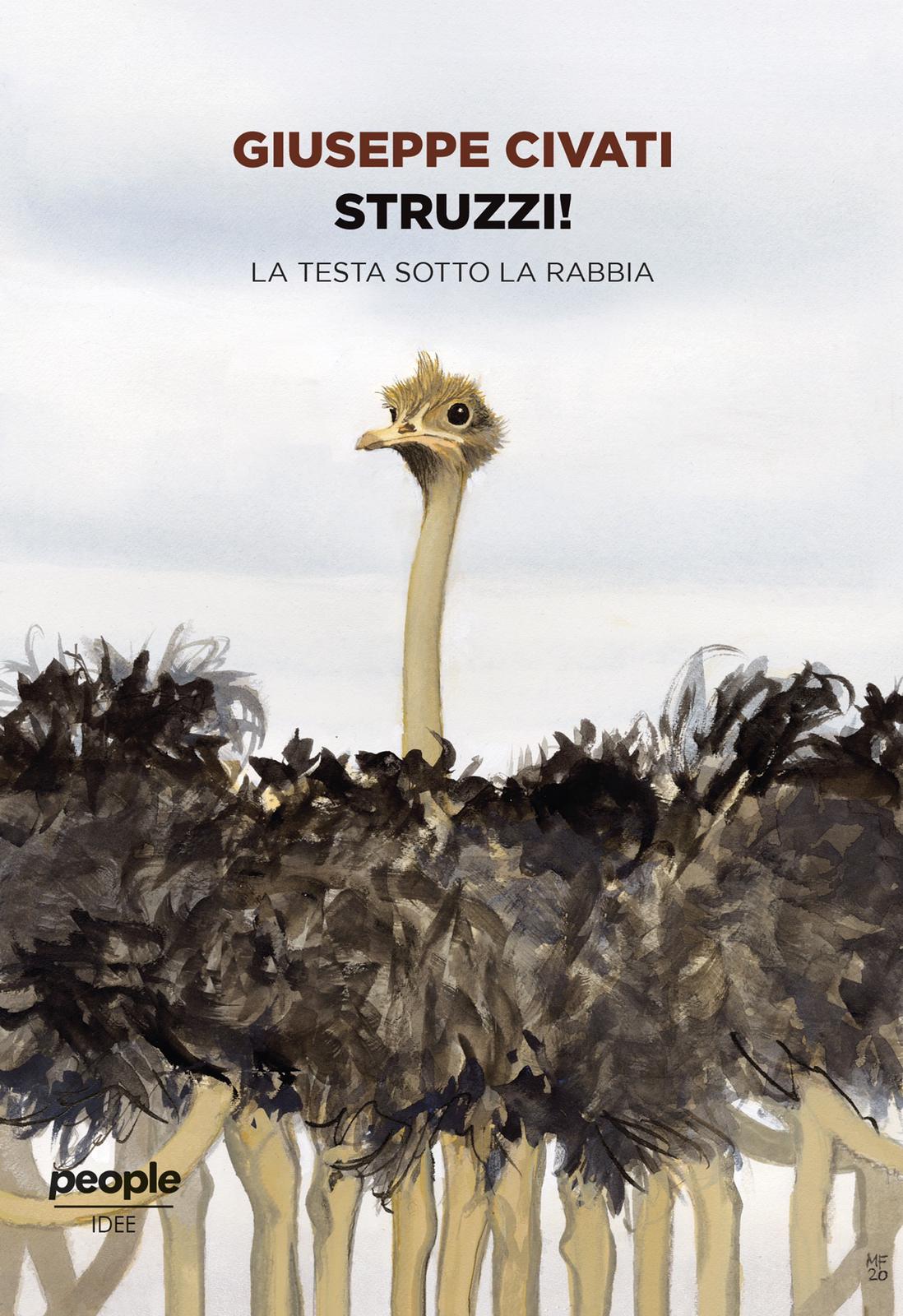








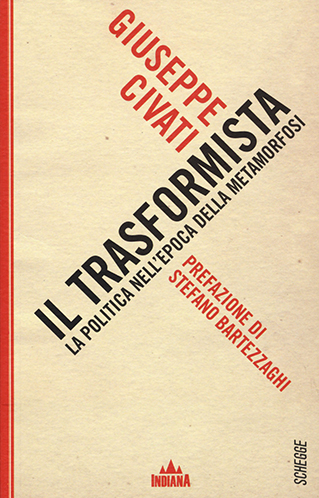


Comments (45)