Sono qui che cammino avanti e indietro, come in quella canzone di Jannacci. Sono un runner lento, domestico. Più nevrotico che atleta. “Sul posto”, direi.
È come una maratona, ma la brutta notizia è che non dura 42 chilometri e 195 metri. Filippide chissà quando arriverà, trafelato, a darci la buona notizia. I Persiani (metafora) chissà quando saranno sconfitti. Νενικήκαμεν, «abbiamo vinto!», chissà quando ce lo diranno.
Il traguardo si sposta ogni giorno, a ogni decreto, e questo elemento di incertezza inquieta. Così come inquieta il fatto che quando tutto sarà finito, non sarà davvero finito. Sarà diminuito. E inizierà una corsa di tipo diverso, non una corsa vera e proprio, più una marcia, direi, per ricominciare. La quarantena dopo la quarantena. E sarà ancora più difficile, perché dovremo farlo insieme ma a debita distanza. Perché avremo la fregola di fare ma dovremo essere cauti. Perché ci saranno molti ostacoli, lungo il cammino, e parecchie macerie da spostare.
Pensando al mitico Gianni Mura (leggete il bellissimo necrologio di Maurizio Crosetti), i colli da scalare sono più d’uno, come un tappone pirenaico. Ne passi uno, hai l’ebbrezza della discesa ma dura poco e si ricomincia a salire. Unica differenza: i tifosi sono tutti a casa propria. Il silenzio è irreale.
Come sanno i maratoneti e gli appassionati, si chiama muro quel momento in cui crolli, in cui ti sei gestito male, in cui hai sprecato, in cui hai tenuto ritmi che – lo scopri all’improvviso – non avresti potuto mantenere. Che forse è anche una metafora ancora più grande, perché si riferisce al modello di sviluppo, alle corse pazze fatte finora da un sistema esposto al collasso. Fragile esso stesso.
Parlando di oggi, il muro del trentesimo chilometro è ancora lontano, ma noi siamo già a corto di risorse.
Lo siamo collettivamente, perché abbiamo continuato a muoverci troppo, in questi primi giorni di quarantena, e finalmente si è deciso di fermare tutto ciò che si può fermare. E non è polemica verso nessuno (che pare un reato), però è tutto scritto nelle dichiarazioni di fine febbraio (!), nell’insistenza di alcune aree del paese nel voler continuare – business as usual – a tutti i costi, nel sottovalutare il rischio che così si è fatto correre a tutti, nelle scelte contraddittorie di molti, troppi.
Lo siamo individualmente, perché non ci siamo abituati, non lo avevamo messo in conto, non lo sapevamo. Ieri sera siamo stati svegli per scoprire insieme quale fosse la febbre del sabato sera, aspettando una diretta da Palazzo Chigi. Sul divano, in sala: sala d’attesa. Nessuno, nemmeno Conte, lo avrebbe mai messo in conto. Ogni pomeriggio aspettiamo i dati del contagio con la stessa ansia con cui si attendono i risultati delle elezioni e tutti paiono aver fatto un corso accelerato di statistica. Da commissari tecnici a virologi in pochi giorni. Il virus muta, dice.
Dobbiamo mantenere un equilibrio che nelle nostre vite, nelle nostre società è già precario. Impacchi di stoicismo, ci vogliono. E buone dosi di fiducia. Lo dobbiamo soprattutto a chi è costretto a stare in giro, ad avere millemila contatti con le persone, a affrontare emergenze. I medici e tutto il personale degli ospedali, a cui deve andare tutta la nostra cura. E le persone che consegnano pacchi, stanno in cassa, puliscono e sanificano (la parola più nuova che sia entrata nel nostro vocabolario). A tu per tu con il virus, diciamo.
Sono certo che tutta la comunità nazionale saprà dotarsi degli strumenti adeguati – necessari – per sostenere loro. Per prendersi cura di chi si prende cura di noi. Pensiamo a loro, quando ci annoiamo. Pensiamo che le loro giornate sono così piene, tanto quanto le nostre ci paiono svuotate. È questo l’inno che dobbiamo cantare, al di là dell’inevitabile retorica che ci accompagna: è questa la vera sfida dei prossimi giorni. E speriamo che anche Filippide, questa volta, sopravviva.


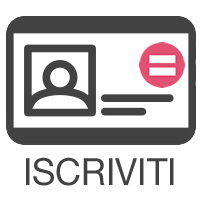






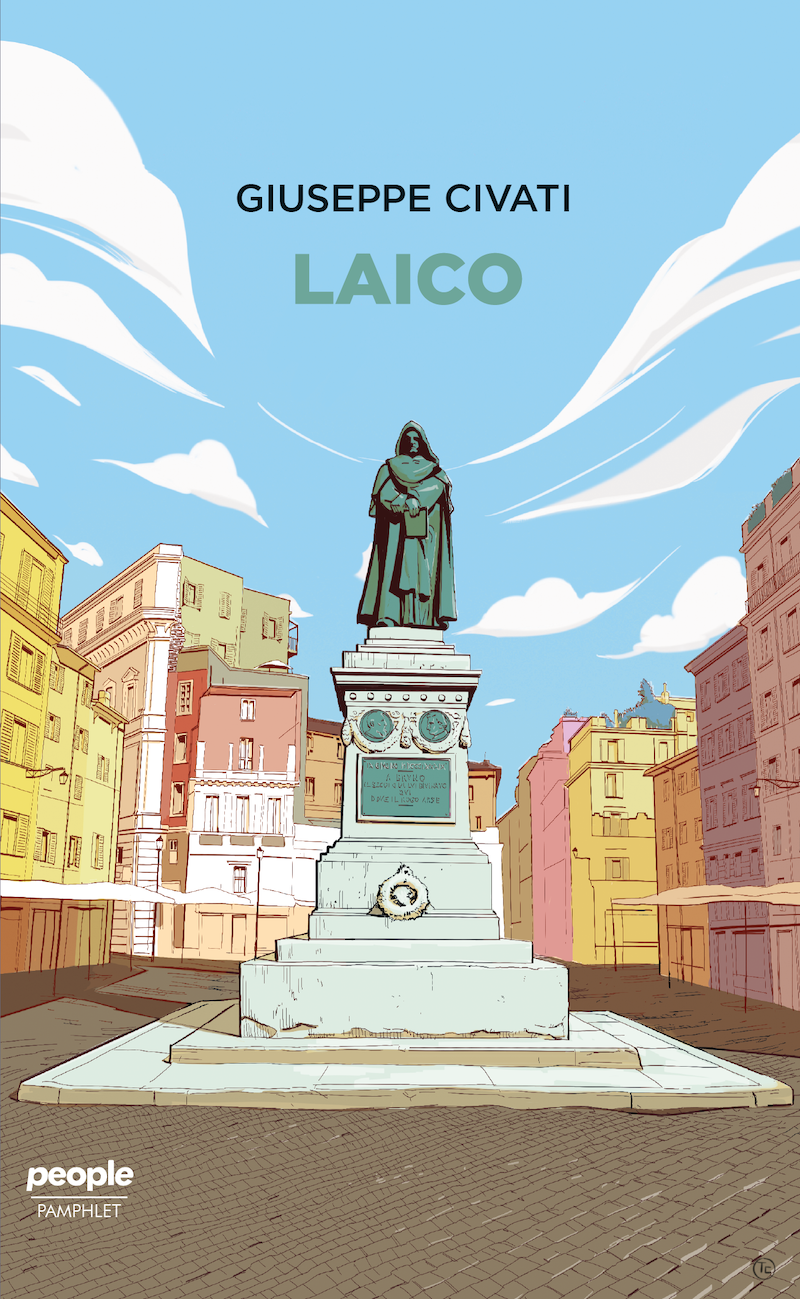

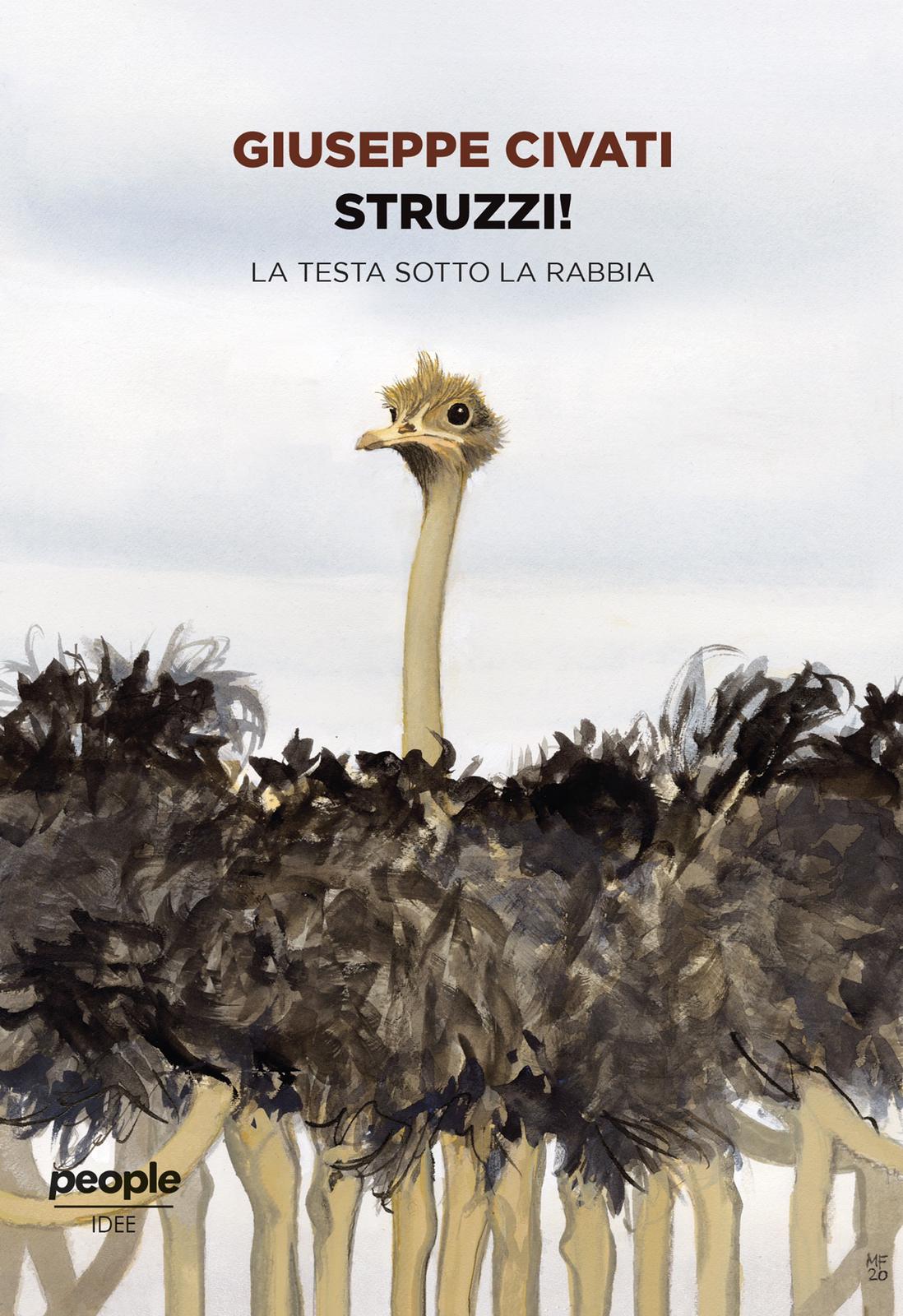








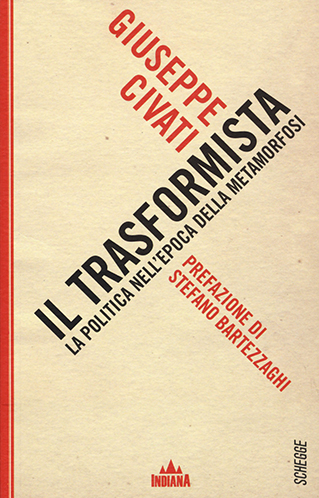


Comments (0)