Il 6 maggio del 2015 sono uscito dalla maggioranza e quindi dal partito che la guidava, attraverso il segretario-premier di allora.
Erano i giorni della tripla fiducia sull’Italicum – dichiarato poi incostituzionale nel suo cuore, il ballottaggio con premio, a prescindere dal risultato referendario -, della Buona scuola, della lunga coda di discussioni intorno al Jobs Act e allo Sblocca Italia.
Molti non capirono, allora. Quelli della «ditta» mi rimproverarono duramente: molti di loro sono usciti qualche settimana fa.
Altri dissero che ero velleitario, che tanto sarebbero rimasti tutti dentro al partitone del dentro-tutti (si pensava così allora), anche se aveva preso una piega davvero brutta. I dati delle primarie 2017 confermano invece che quella che chiamavo «diaspora» era prepotentemente in corso, soprattutto tra i militanti e gli appassionati del centro nord, che erano stati la larga maggioranza delle 400.000 persone che avevano votato per la mia proposta congressuale nel 2013: al voto sono tornati soltanto la metà di quelli che ci erano andati allora.
Altri ancora dissero che il partito andava cambiato «da dentro»: non mi pare che ci siano riusciti (anzi, le cose sono andate peggiorando) e in alcuni casi, a cambiare «da dentro» sono stati loro.
Non era un calcolo, il mio: sapevo di sparire dai grandi mezzi di comunicazione e di finire schiacciato nel gioco dello #specchioriflesso tra Pd e M5s, che continua ancora. Oggi siamo alla batracomiomachia dei topi degli uni e degli altri e a parole e opere che fanno pensare che stanno tutti diventando sfumature di destra, chi per la Dottrina Minniti e la difesa legittima mutuata dagli altri, chi per le Ong e il cinismo elettorale più smaccato.
La mia era una scelta di sincerità: non potevo continuare a votare cose che non condividevo, a cominciare dalla riforma costituzionale che contrastai in aula anche quando stavo in maggioranza, tra le risatine e le alzate di spalle di chi magnificava la riforma boschiva. Ma soprattutto – e politicamente – non condividevo un modello politico basato sulle larghe intese perenni e sui nazareni, in cui a poco a poco gli outsider (che in realtà, come si è scoperto poi, non lo erano mai stati) diventavano sistema.
Un modello all’insegna del quale non ci si è presi cura della sofferenza del paese, della necessità di ridurre le disuguaglianze, di fare cose semplici eppure importantissime contro i privilegi (stipendi e vitalizi, la cosa più ovvia), di progettare il futuro (vedi alla voce transizione ecologica, ad esempio), di chiedere rigore all’accoglienza, di scrivere riforme condivise e nel potenziare gli strumenti di controllo e di partecipazione per i cittadini. Tutto il contrario.
Per di più, un modello e uno schema che ci hanno portato a un’impasse, perché le ‘grandi’ riforme sono state bocciate nonostante la propaganda populista degli stessi che le proponevano, la legge elettorale è stata dichiarata incostituzionale, non si è affatto ridimensionato lo spazio dei 5 stelle, è cresciuta una destra efferata e fascisteggiante e non è certo aumentata la fiducia dei cittadini. Un capolavoro dietro l’altro.
In questi due anni c’è stato un referendum costituzionale assurdo e devastante, trasformato in elezioni politiche da chi era sicuro di vincerlo, accompagnato da parole irresponsabili da parte di tutti. C’è stata l’esplosione dei voucher e la sensazione che nessuno si curasse più dei diritti più elementari dei lavoratori (poi certo i voucher sono stati cancellati, per paura, però, non per convinzione). C’è stato un referendum sulle trivelle che ci interrogava sulle scelte ambientali di fondo, che è stato disertato dal presidente del Consiglio in carica e dal suo partito. È saltato il centrosinistra, nonostante i continui e stucchevoli richiami all’Ulivo (che era stato trapiantato modello San Foca), nonostante le mille sollecitazioni al voto utile, sempre meno convincente, insomma sempre più inutile.
Sono sparite le bandiere europee, per poi tornare maldestramente in sostituzione di quelle rosse, quasi a vergognarsi dei valori e dei riferimenti ideali, di quelle battaglie che hanno costruito lo stato sociale, le regole e i diritti a favore dei più deboli. Sventolano via.
Si parla di Macron, ma in una logica politica micron, basata esclusivamente su potere e autoreferenzialità.
Ora molti, anche i commentatori che snobbarono la mia scelta di allora, sarebbero d’accordo. Anzi, sarebbero più feroci, meno amari: perché è l’amarezza che accompagna quelli come me, bersagliati dai sostenitori del governo senza capire che prima le mie sono state preoccupazioni, poi certo polemiche, infine disilussioni. Senza rendersi conto che il mio percorso è stato quello di molti elettori e di molti militanti: quelli che poi magari il Pd lo votano lo stesso, ma non partecipano più (perché non si sentono «parte»), non fanno più campagna elettorale, non si sentono coinvolti.
Tutto ciò porta alla rassegnazione, come se questo schema – artificioso come pochi altri nella nostra storia politica – fosse naturale. Come se (ancora!) non ci fossero alternative. Come se il «meno peggio» non continuasse a peggiorare fino a diventare qualcosa di irriconoscibile.
A due anni di distanza, lo dico ancora, anche alla luce di ciò che è accaduto nel frattempo: non rassegniamoci all’attuale quadro politico. Le stesse presidenziali francesi (il cui significato vero si avrà solo con le elezioni legislative di giugno) ci dicono che dare per scontato uno schema elettorale molto prima del voto non ha alcun senso, di questi tempi: un anno prima il candidato che si è qualificato per primo non esisteva. Chi è partito dall’estrema sinistra ha visto raddoppiare i propri dati nel breve volgere di poche settimane.
Non rassegniamoci all’idea che sia tutto uno scontro tra tifosi, che passano la maggior parte del tempo a insultarsi a vicenda, non a parlare di ciò che farebbero ma di quanto siano pessimi gli altri. Non rassegniamoci all’idea che tutto si risolva in una contrapposizione tra sistema e antisistema, speculare, senza progetti se non quelli della demolizione dell’avversario e dell’affermazione di se stessi.
Non rassegniamoci al «se niente importa» va bene tutto, anche fare una legge sulla legittima difesa pasticciata e ammiccante, che peggiora la legge esistente, tra il ridicolo e l’inquietante, facendo un regalone alla destra più stronza.
Non rassegniamoci, perché se ci rassegniamo siamo fottuti: progettiamo insieme un Paese diverso, che ancora non c’è, non rilevato dai sondaggi e dai talk show, con le persone che vorranno mettersi in discussione, unendo tutti quelli che non si vogliono, appunto, rassegnare.
Non rassegniamoci alle cose popolari, che parlano alla pancia con la pancia, tipo un dialogo tra ventriloqui. Facciamo diventare popolari cose che non lo sono, che sono trascurate e neglette. Come il rispetto delle persone e della legge.
A sinistra, certo, ma soprattutto in favore della Repubblica. Per gli elettori di oggi ma soprattutto per gli elettori di domani a cui stiamo consegnando un paese più povero e sconsolato, passivo per certi versi e aggressivo quasi sempre. Ci vuole un patto repubblicano ritrovato, a livello nazionale e europeo come se fossero la stessa cosa, senza soluzione di continuità. Ci vuole la misura che ora manca, ci vogliono gli investimenti coraggiosi che nessuno fa (parola scomparsa dal dibattito, non a caso), ci vogliono scelte radicali perché chiare, coerenti, nitide. E ci vuole la libertà per farlo, che la classe politica che governa non ha più. E ci vogliono insomma laicità e rigore, speranza senza propaganda, parole senza inganni.
Bisogna essere liberi per volerlo diventare.


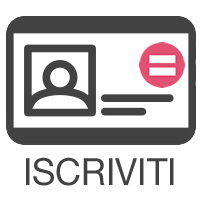






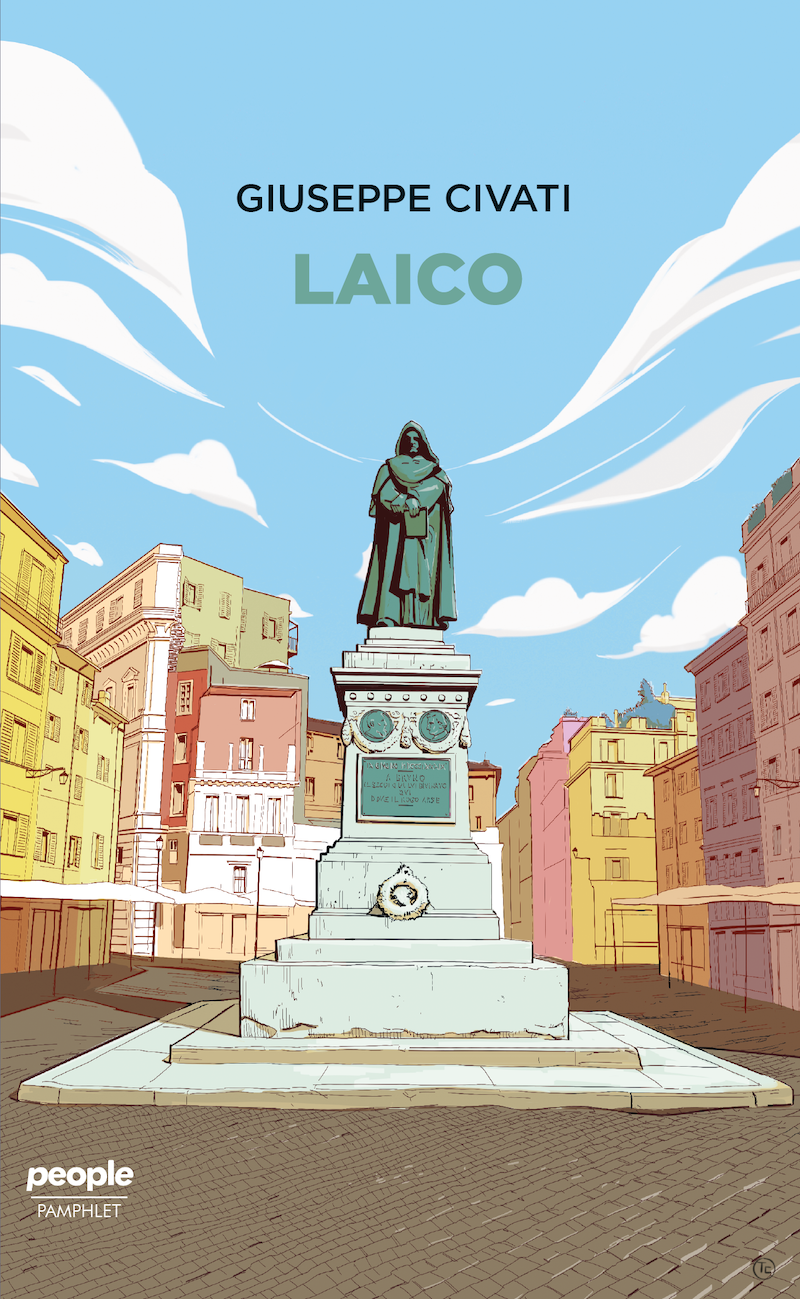

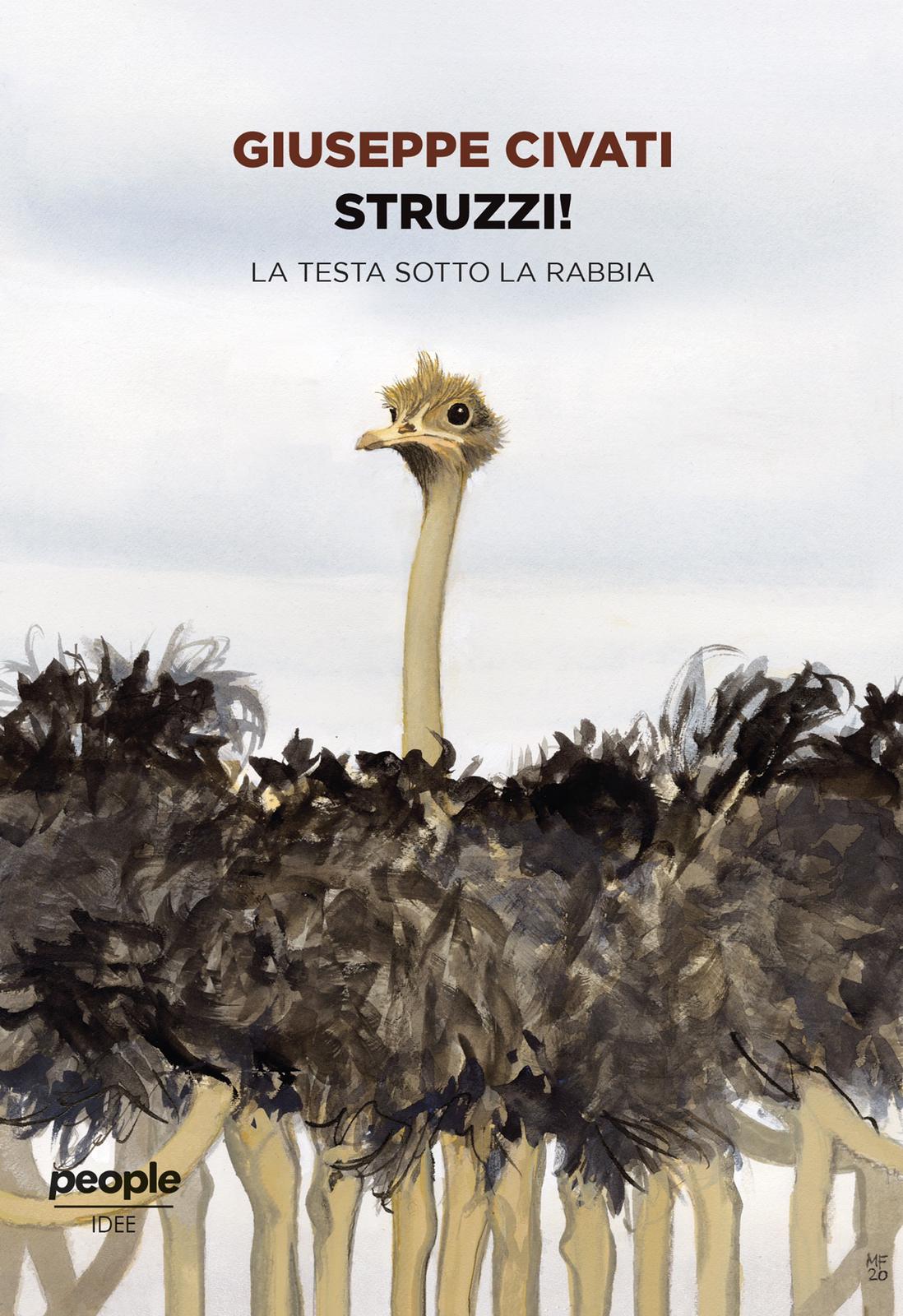








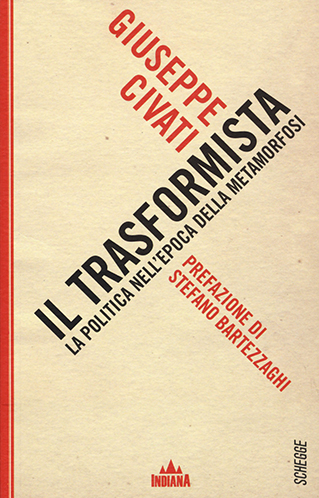


Comments (0)