Non bisogna aver letto Paul Mason (però leggetelo, mi raccomando, sta per uscire in italiano) per capire che le cose non funzionano più. E non funzionano più perché stiamo usando le ricette degli anni Ottanta per affrontare una trasformazione che cambia connotati e sostanza ai processi produttivi, alle relazioni lavorative e industriali, alla vita stessa dei lavoratori (sia che un lavoro ce l’abbiano, sia che l’abbiano perso, sia che lo stiano cercando).
Lo si può notare muovendo dal punto di vista delle partite Iva di cui ci eravamo occupati lo scorso anno, per evitare che alcune modifiche fossero inserite a tradimento e a nocumento dei lavoratori autonomi, soprattutto quelli di nuova generazione. Per una volta il governo aveva fatto marcia indietro e si era dato un altro anno di tempo.
Dobbiamo fare, allora, un passo indietro, perché a volte ci si infila in discussioni talmente lunghe che dopo un po’ non si ricorda più il motivo per cui sono iniziate, e si va avanti solo per discutere della discussione stessa. La generazione cui anche io appartengo (e tutte le successive) è impegnata da vent’anni in una conversazione sul lavoro, sul mercato del lavoro e in definitiva sul proprio destino, ma quello che è successo nel frattempo è che mentre i primi precari della storia della nostra Repubblica sono invecchiati e si avviano ad avvicinarsi a un’età della pensione che non riceveranno mai, nel tempo la discussione sul lavoro si è tramutata in una discussione sulle riforme del mercato del lavoro, e questa tendenza invece di risolversi con l’avvento al potere della prima classe dirigente anagraficamente e generazionalmente interessata al fenomeno ha raggiunto invece il suo apice.
Non si discute quindi più di lavoro, si discute di Jobs act: la riforma non serve a risollevare i brutti dati occupazionali, ma sono i dati – distorti – che servono a giustificare la riforma. Ma da cosa eravamo partiti, qualcuno se lo ricorda? Perché stiamo facendo questa discussione interminabile?
È bene ricordarlo: stiamo facendo questa discussione perché, ad un certo punto, il sistema produttivo italiano sempre più connesso a quello globale ha smesso di generare posti di lavoro in grado di permettere alle persone di fare una vita decorosa.
Stiamo facendo questa discussione perché da vent’anni chi entra nel mercato del lavoro lo fa da solo, senza rete, costretto a formule incomprensibili e vessatorie, caricandosi rischi di cui lo Stato si disinteressa, il datore di lavoro o committente pure, e che semplicemente non solo sostenibili; non trova garanzie, viene pagato meno, non ha tutele, e quella che sarebbe già discutibile come situazione transitoria o quantomeno iniziale diventa invece definitiva: la stabilizzazione dell’instabilità.
Lavori precari che non diventano mai a tempo indeterminato, che non accedono mai alle stesse tutele, che non portano mai agli stessi livelli retributivi di chi “c’era prima”, che costringono a cambiare spesso, a non capitalizzare l’esperienza accumulata, a essere sostituiti da altri più ulteriormente più economici per il datore di lavoro, in una spirale al ribasso infinita, non valorizzano le competenze di chi non svolgerà mai le mansioni per cui ha studiato o sarebbe qualificato, non consentono di pianificare il proprio futuro, non consentono di acquistare casa, di creare una famiglia, di risparmiare, di consumare. E, in poco tempo, un Paese ricco diventa un Paese povero.
Ora, la domanda è: adesso che il Jobs act è riuscito nell’impresa di rendere determinato anche il tempo indeterminato, per tacere del resto, i lavoratori di domani avranno quelle risposte che i lavoratori degli ultimi venti anni disperatamente hanno cercato? Avranno la stabilità, le tutele, i diritti?
Proprio in questi giorni si torna a parlare di partite Iva e di lavoratori autonomi, quindi: allora non erano spariti, dopotutto, la riforma salvifica con le sue slide in powerpoint se li era solo dimenticati. E come stanno, i lavoratori autonomi, in questo nuovo mondo? Come sta Daniela Fregosi, 46 anni, partita Iva dal 1992, ammalata, senza tutele, senza diritti? Il suo caso, e la campagna di Acta sul disegno di legge sul lavoro autonomo, ci riportano dolorosamente alle questioni fondamentali per cui molti di noi si battono da vent’anni.
Con le mance regalate a chi ha già un certo livello di entrate (ma solo se dipendente, come se quello che gli stessi sostenitori della riforma chiamano «apartheid» non fosse già più che sufficiente) si poteva creare una forma di reddito di sostegno per chi, specialmente lavoratore autonomo, passa periodi dell’anno tra un’occupazione e l’altra. Si potevano accorciare i tempi di pagamento, perché per una partita Iva 90 giorni prima di veder corrisposta una fattura possono essere fatali; si poteva garantire una copertura maggiore per la malattia, almeno quella.
Con la banale riforma degli 80 euro che vanno (in buona parte) a chi non ne ha bisogno, si sarebbero potuti trovare miliardi di euro da destinare a chi non solo non li riceve gli 80 euro (benché guardagni le stesse cifre di coloro che li ricevonoo), ma non ha altri strumenti di supporto e di tutela. Con una riforma in senso progressivo del fisco, si poteva consentire agli italiani (e alle italiane soprattutto) di sentirsi trattati tutti (e tutte) nello stesso modo, a parità di condizioni di reddito e di patrimonio. Perché una vera progressività prelude a una possibile uguaglianza.
Usiamo l’imperfetto, ma si può passare all’indicativo presente. Ragionando in un altro modo. Leggendo le trasformazioni e cercando di anticiparle. Scoprendo che il lavoro e i suoi strumenti sono cambiati, che le retribuzioni sono troppo basse, che così il paese si impoverisce e si perde.
Paolo Cosseddu un giorno disse che ci voleva una class action di tutti quelli che si sentono discriminati: perché lo sono. Un modo per dire che ci vorrebbe un programma diverso. E un governo diverso.


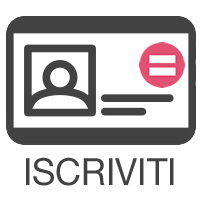






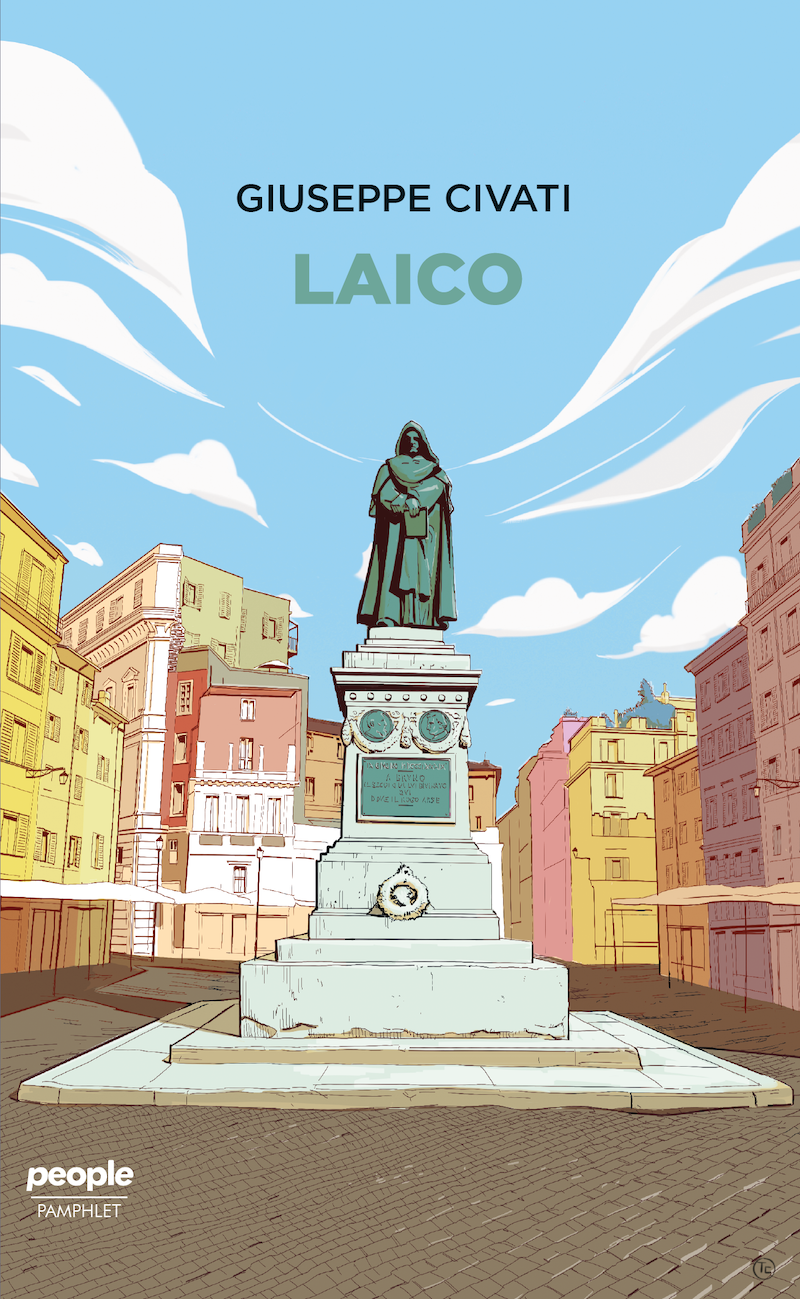

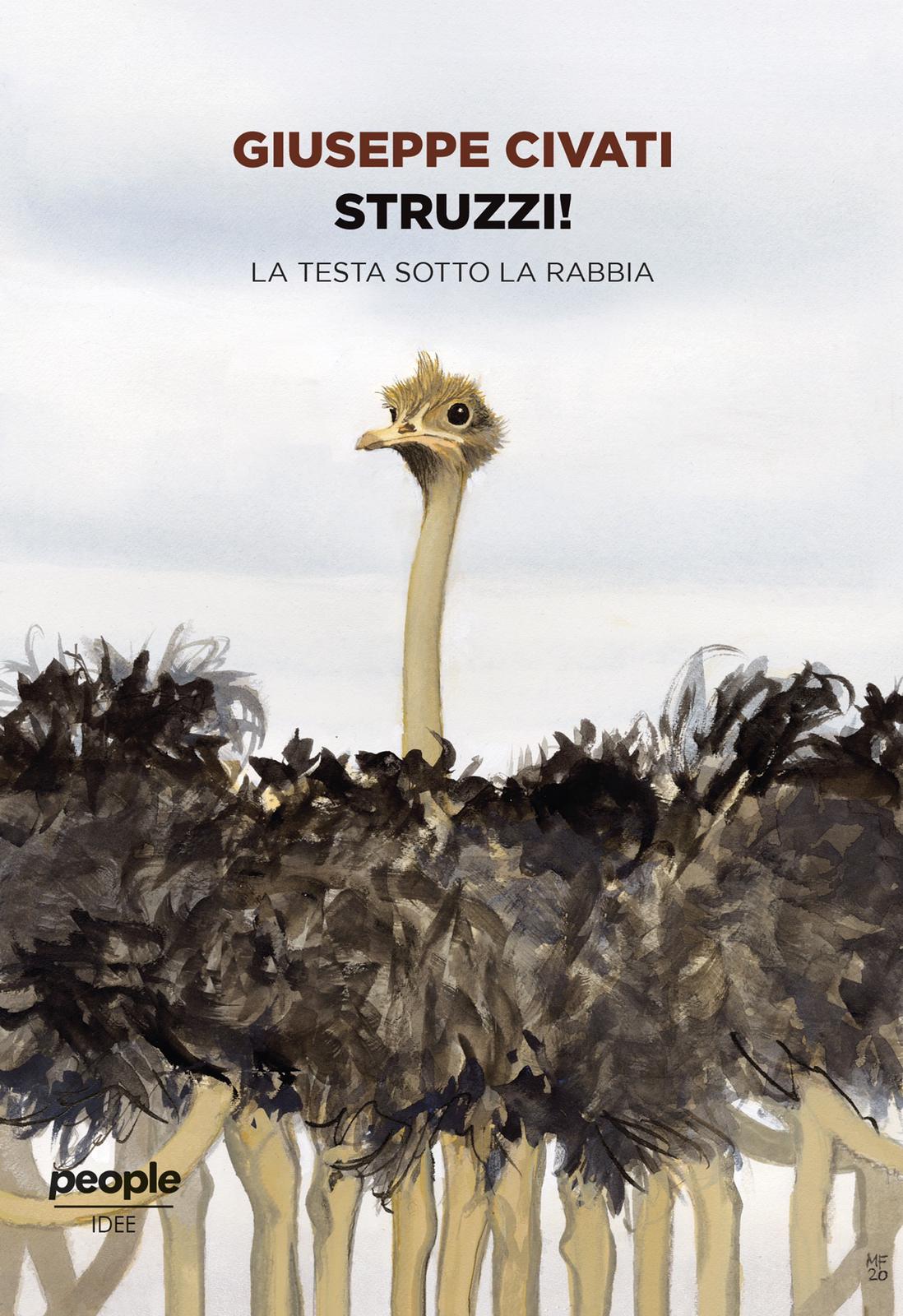








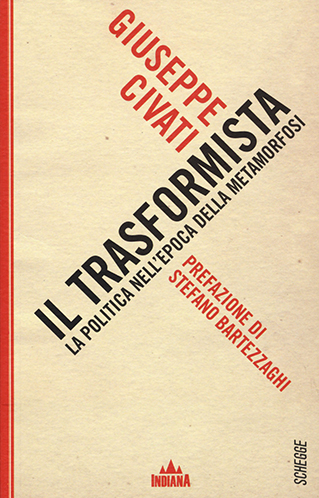


Comments (0)