Ne parla Walter Tocci nel suo Sulle orme del gambero. Ragioni e passioni della sinistra, in uscita per Donzelli. Un libro con cui mi confronterò spesso, nei prossimi giorni, invitandovi a leggerlo e a discuterlo in questa e in altre sedi.
Quelle pagine dedicate al riformatore ottimista mi hanno fatto venire in mente un articolo folgorante di Paolo Di Paolo, che vi riporto qui sotto. S'intitola «Quest’insopportabile dittatura del pessimismo». Un testo da cui ripartire, subito, prima che sia troppo tardi. E prima che qualcuno ci dica che lo è già, troppo tardi. Perché il pessimismo invita al conformismo, blocca la creatività, cancella la libertà. Non ci sono alternative, ci sentiamo ripetere, magari da chi per anni ha fatto promesso impossibile. Invece un'alternativa c'è, ed è possibile.
In settimana, saltando fra i due o tre talk-show politici in onda in contemporanea, sono stato preso dallo sconforto. Alcuni si sono distinti per bruttezza: lugubre perfino la scenografia. I dibattiti sembravano dischi incantati non da un giorno ma da vent’anni; c’era qualcosa di surreale e insieme di asfittico. Gli schiamazzi, gli accessi di rabbia, il tono di cupezza generale. Tutti i discorsi avevano come prospettiva non l’anno o almeno il mese a venire, ma mercoledì e giovedì prossimo. Dalle analisi di molti parlamentari affiorava un’aria da fine di partita, da apocalisse imminente.
In sostanza, un pessimismo rabbioso, ottuso, concentrato forse più sul proprio destino politico che sul futuro dell’Italia. Un pessimismo alimentato da un vocabolario da troppo tempo irrigidito sugli stessi termini: crisi, baratro, disastro. Spesso senza nemmeno partire da dati concreti – sulle industrie, sulla manifattura, sui precari -, senza la volontà di analizzarli, ma solo per agitare in faccia all’avversario il solito spettro dell’abisso.
C’è qualcosa di autolesionistico, in questo tenere gli occhi bassi e torvi solo sulla settimana in corso, senza alzarli mai verso qualcosa che potrebbe prospettarsi appena più in là, in un luogo che una volta si chiamava «futuro». C’è qualcosa di autodistruttivo in questo insistere solo sul negativo, sul peggio; nel trasmettere a chi ascolta – e magari in effetti è in difficoltà – la sensazione di un precipizio in cui può da un momento all’altro rovinare. C’è qualcosa di ingiusto, direi di ingeneroso nell’alimentare da anni un discorso solo in negativo, portando a esempio solo ciò che non va, ciò che non funziona, ciò che preoccupa. Mai, mai ciò che sta in piedi, ciò che dà respiro, ciò che dà speranza. Sono stanco. In questa colla di malumore, in queste sabbie mobili di pessimismo, per ogni piccolo slancio su cui saremmo disposti a investire, si fatica il triplo; in quest’aria gravida di minacce ogni iniziativa, progetto, scommessa assumono i contorni di un’impresa donchisciottesca. Ma appunto, spesso si tratta di mulini a vento e non di veri ostacoli; montagne di parole sbagliate, inquinate, cattive che girano a vuoto come le braccia dei finti giganti davanti a don Chisciotte e al suo scudiero. l disincanto è piovuto nelle minestre degli italiani ogni sera per troppi anni: in parte dovuto, motivato; in parte superfluo, immotivato come la paura del buio. Tutto sta crollando? Allora tanto vale essere più diffidenti, più cinici, anche più pigri. Tanto vale mettersi al riparo.
Se la classe politica non è generosa, non lo saranno neanche i cittadini. Non è questione soltanto di sprechi, di vantaggi personali, di indecenze; è questione anche di offrire idee, prospettive, risorse intellettuali e perfino emotive. Non i sogni di miracoli italiani impossibili, sogni di finto benessere, ma altro: lo spazio prima di tutto mentale dove la speranza e il coraggio, l’intraprendenza e un progetto – di lavoro, di vita, di serenità – siano ancora praticabili. Chi adesso sta per compiere tredici anni come il nuovo secolo, può essere tenuto in ostaggio da questa luttuosa e in- terminabile stagione, da questa infinita penombra? Quando avrà venti o trent’anni gli racconteremo che eravamo alle prese con la decadenza di Berlusconi e non avevamo risorse per frenare un’altra e infinitamente più grave decadenza? La decadenza dell’entusiasmo, della passione, di idee ed energie nuove.
Un uomo conosciuto in tutto il mondo come Renzo Piano, settantasei anni, ha detto in un’intervista: «Non esiste una nazione meglio attrezzata per affrontare un futuro di economia sostenibile. Siamo il Paese più bello del mondo e la bellezza è oggi la merce più ricercata. Abbiamo immensi giacimenti culturali, una miscela unica di meraviglie naturali e costruite nei secoli, una posizione centrale nel Mediterraneo, una situazione climatica ideale per produrre energia pulita…». Una boccata d’ossigeno. Parlare così significa forse nascondere i problemi, che pure ci sono? No, significa progettare. E un architetto è abituato a farlo, si dirà, è il suo mestiere. In Italia si sta smettendo di farlo, di progettare a lunga scadenza; la coltre di pessimismo che tutto avvolge rischia di scoraggiare anche i più volenterosi.
Una delle città invisibili di Italo Calvino si chiama Tecla, è un cantiere: impalcature, armature metalliche, ponti di legno, gru. Chi vi arriva, domanda agli abitanti che senso abbia quel costruire: dov’è il piano che seguite, il progetto? «Te lo mostreremo appena terminata la giornata; ora non possiamo interrompere» rispondono. «Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. “Ecco il progetto” dicono». Stiamo rinunciando a essere ciò che un Paese, una società devono essere sempre: un perenne cantiere, ovvero un progetto. Stiamo rinunciando all’ottimismo e alla fiducia che lo rendono possibile, che lo tengono vivo.


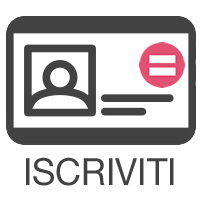






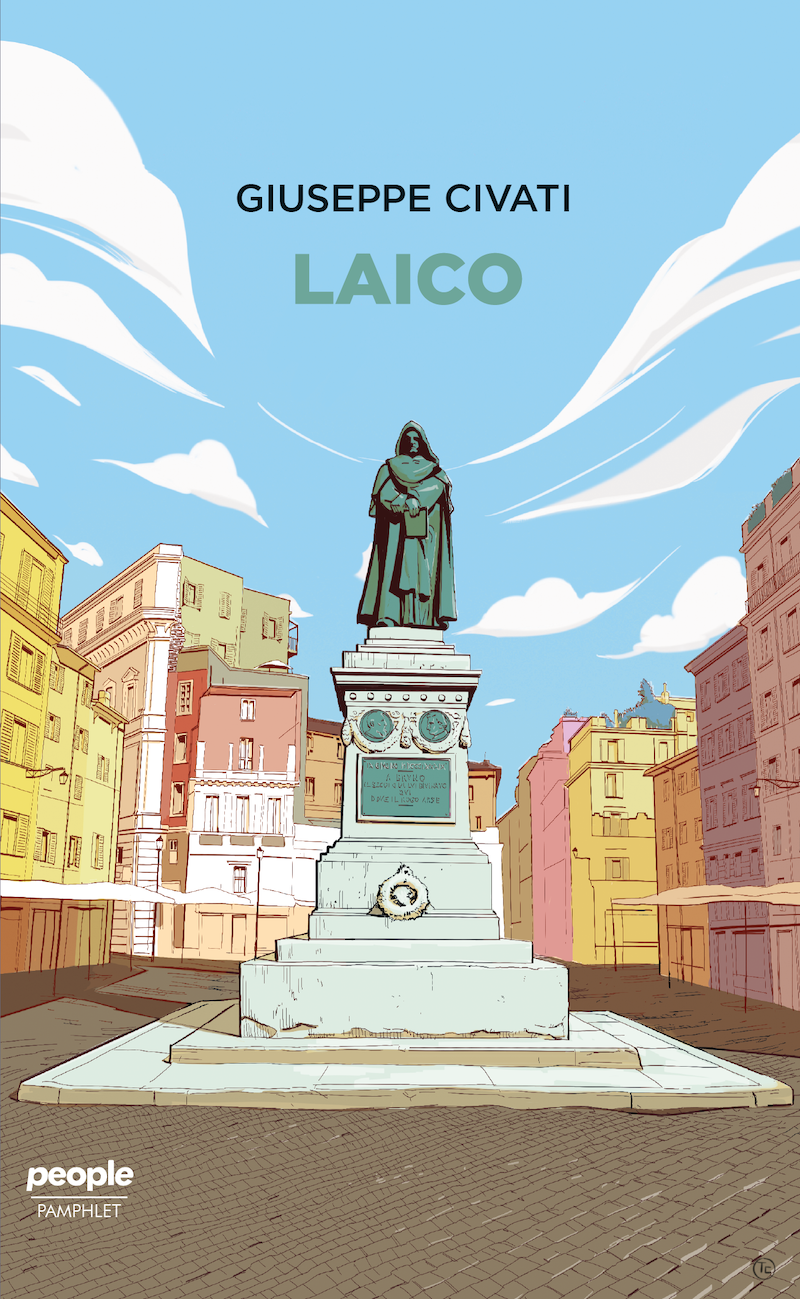

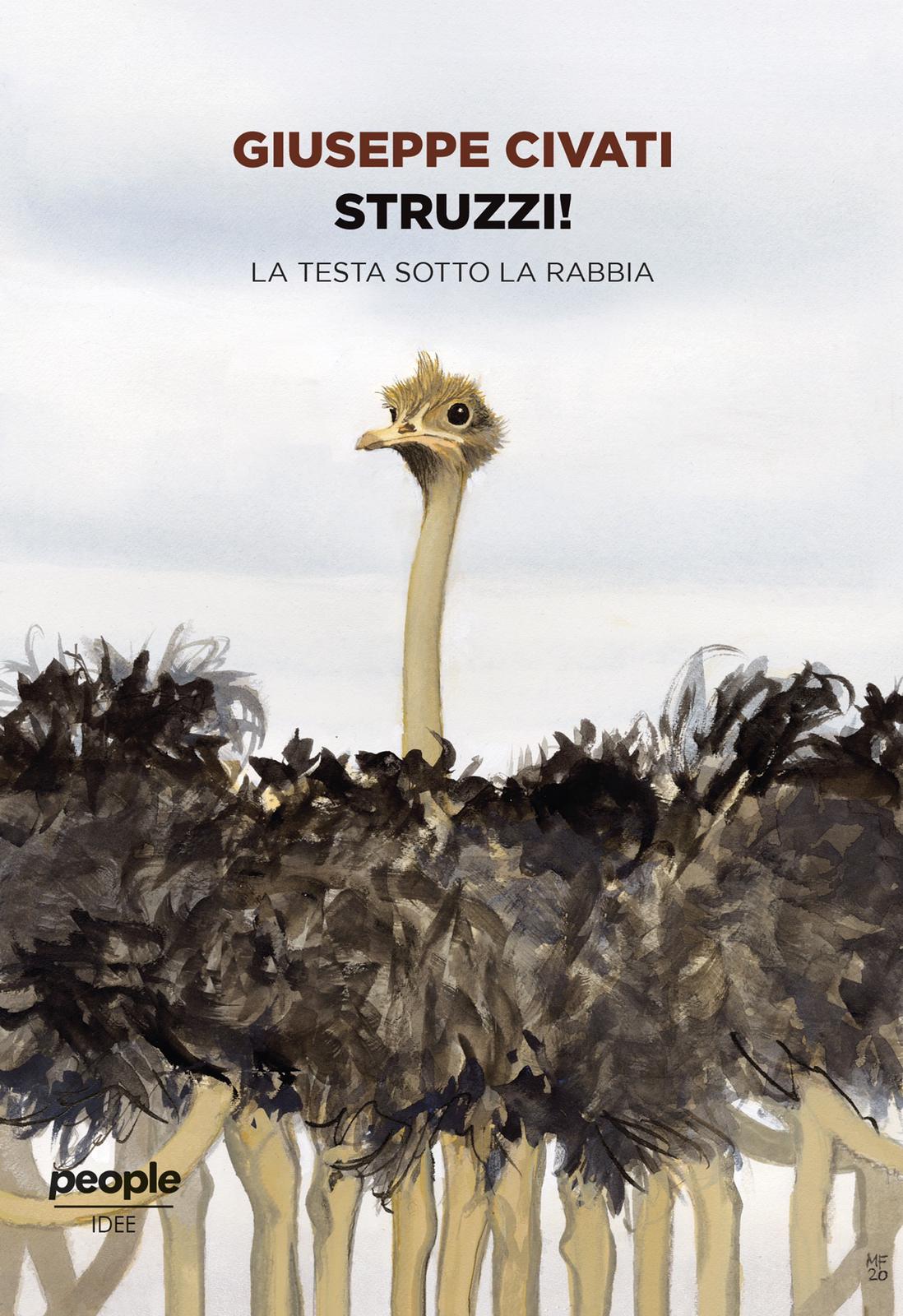








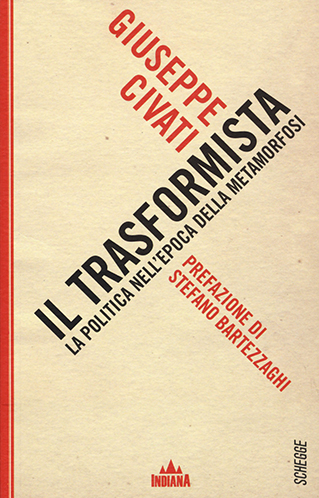


Comments (71)